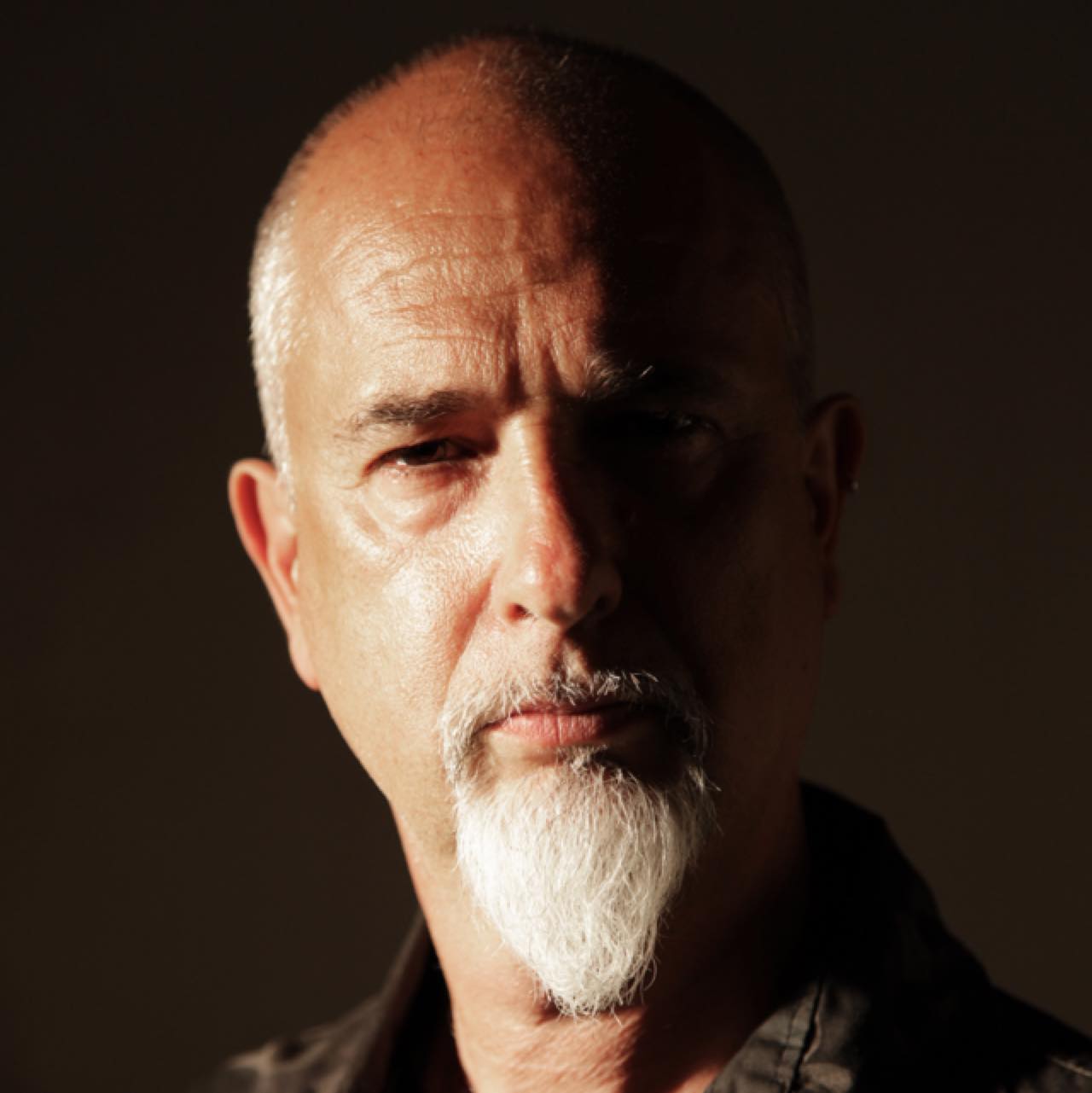“La Brexit? E’ una cagata. Ma almeno per noi non ha mai rappresentato un problema: ci siamo trasferiti a Londra definitivamente nel 2016. A novembre anzi chiederemo la doppia cittadinanza: Potrebbe fare comodo, soprattutto per mia figlia, che ora ha nove anni”: comincia così la chiacchierata con uno dei musicisti italiani viventi che più ammiriamo, Eraldo Bernocchi. Parla di sé, della famiglia (costruita con Petulia Mattioli, fotografa e video-artista, da sempre musa e compagna insostituibile), parla di mille altre cose in questa chiacchierata a briglia sciolta che parte da quanto farà a Roma in questi giorni alla Fondazione Nicola Del Roscio, stasera 20 e domani 21 maggio, assieme ad uno dei musicisti più affascinanti del pianeta – il trombettista Nils Petter Molvaer, geniale maestro degli incroci tra elettronica, jazz e folk – e alla già citata Petulia. “Like A Fire That Consumes All Before It” si basa sull’opera Cy Twombly, geniale artista americano che ha vissuto a lungo a Roma ed a Gaeta (e di cui Del Roscio è stato a lungo assistente). Un’operazione “colta” che è una delle tante sfaccettature di Bernocchi: vulcanico (oltre cento dischi suoi usciti ad oggi), con collaborazioni di altissimo livello (l’elenco è infinito, in primis da citare il progetto Charged assieme al compianto Toshinori Kondo ed a Bill Laswell, che stregò perfino la R&S, o ovviamente le collaborazioni coi leggendari Harold Budd e Robin Guthrie), capace di lanciarsi a corpo morto nelle sfide sonore (fin dai primi passi del suo progetto-madre cronologicamente parlando, i Sigillum S). Una di quelle menti musicali rare e preziosi che ragionano senza steccati, e che cercano di combinare qualità ed emozioni, concettualizzazioni e sfide senza rete. Con lui parliamo di tutto questo, di come ha lambito i mondi del pop, di come ha assistito al naufragio degli ultimi spasmi del sodalizio tra Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, dell’amore (problematico, ma intenso) con la techno. Davvero: personaggi così, in Italia, ce ne sono davvero pochi. Un gigante.
Quello che succederà a Roma è molto interessante, anche perché il tuo sodalizio artistico con Nils Petter Molvaer è una faccenda abbastanza di lunga data, se non sbaglio…
Oh sì. E’ stato direttamente Bill Laswell a farmelo conoscere, e intendo di persona, visto che ovviamente Nils musicalmente lo conoscevo e stimavo da tempo. Ci siamo ritrovati io e Nils a fare un Somma assieme: lui, Laswell, Hamid Drake, Raiz degli Almamaegretta, altri ancora… Ma non solo: abbiamo anche fatto negli anni collaborazioni che, boh, è bene che siano passate un po’ sotto silenzio (come il trio con Massimo Pupillo degli Zu, ma lì diciamo che per vari motivi il risultato non fu soddisfacente), così come robe bellissime come ad esempio un lavoro per Palazzo Strozzi, a Genova, lavorando anche in quel caso su una video-installazione di Petulia. In un modo o nell’altro, sono quasi vent’anni che io e Nils collaboriamo. Mi sento molto fortunato in questo.
Questa cosa di Roma legata a Cy Twombly come nasce, e come la svilupperete?
Lavorando in maniera molto semplice. L’idea di chiamare Nils fra l’altro non è stata nemmeno mia ma proprio di Petulia. In origine i committenti volvevano tanto avere Harold Budd, Robin Guthrie e me, evidentemente affascinati dal nostro progetto a tre; ma ecco, diciamo che non era particolarmente possibile, visto che Harold non è più tra noi (sorride ironico, NdI). Robin ho anche provato a chiamarlo, ma: “Eraldo, guarda, non salgo su un palco da quattro anni e ti dirò – sto bene così”. Lui in effetti ormai si dedica solo alle produzioni, sta facendo un sacco di colonne sonore per serie di Amazon Prime. “Sarei disonesto se ti dicessi di sì. Sarei fuori posto, fidati. Grazie per l’invito, ma no”. Al che lì mi è è arrivata in aiuto Petulia, che mi ha fatto notare che di tutti i musicisti che conosco l’unico che poteva avere la stessa delicatezza e leggerezza del tocco di Harold era Nils. L’ho chiamato, ha accettato subito, con entusiasmo. Anche perché giusto un paio di mesi prima ci eravamo incrociati e ci eravamo proprio detti “Dai, dai, speriamo di fare qualcosa assieme a breve di nuovo…”. Io avevo già musicato un documentario su Cy Twombly, creato da Andrea Bettinetti, quindi a Nils ho mandato quattro, cinque pezzi di quella roba lì. Ma anche un po’ di materiale nuovo, ovvio. Obbligatoriamente del materiale nuovo.
Obbligatoriamente?
Io non riesco a lavorare solo su musica che già ho fatto. Per me i dischi, una volta che sono finiti e sono usciti, diventano subito parte del passato; diventano dei figli maggiorenni, che possono uscire da casa e andarsene in giro per il mondo senza dovermi rendere conto più di nulla. Anche perché parliamoci chiaro: io non sono Ennio Morricone.
(Il trio con Harold Budd e Robin Guthrie; continua sotto)
Cioè?
Non sono uno di quegli artisti dal repertorio incredibile. Non ho una “L’estasi dell’oro” che posso fare anche da vecchio, sordo e stonato ma viene fuori comunque un capolavoro: no, io sono un musicista normale, come tanti. Uno a cui alcune cose vengono magari bene ed altre invece insomma, ma non sono uno che ha in archivio dei capolavori immortali, su cui è giusto tornare e tornare. Ad ogni modo, ti dicevo: ho mandato a Nils un po’ di materiale nuovo. Adesso in queste ore si tratta di fare selezione. Non dobbiamo infatti suonare tantissimo, parliamo di 45/50 minuti, non di più. Ancora ancora il sabato possiamo sforare, superare l’ora, quando la cosa sarà aperta al pubblico. Il venerdì invece ci saranno solo galleristi ed addetti al settore: ho come il sospetto che passati i 50 minuti rischiano proprio di rompersi i coglioni.
Creare musica per te è un processo lungo, complicato e faticoso, o ti viene invece facile e veloce? Che a vedere quanto è sconfinata la tua discografia…
Beh, dipende. Davvero: dipende. Le energie emotive sono quelle che mi fanno partire, che mi fanno decidere di intraprendere qualcosa: le utilizzo insomma prima, non tanto durante, o dopo. Sai, io a livello di ispirazione lavoro soprattutto per immagini. Cose che vedo, che scopro, che incontro anche per strada. Che so: una coppia che si bacia davanti ad un cancello, e il suono particolare che fa quel cancello lì quando si chiude diventa la scintilla per pensare a qualcosa da comporre. Ogni tanto la concettualizzazione è più “quadrata”, più cioè a monte: con Sigillum S ad esempio è sempre così – a parte i nostri primi dischi, che erano veramente selvaggi, un buttarsi senza rete – e anche per dire nel disco che sta per uscire con Merzbow, che di suo è una manata potentissima come impatto, c’è in realtà un lavoro di concettualizzazione preliminare piuttosto preciso. Ciò che però veramente mi porta via tempo e rende più complicate le cose è la fase di produzione, di mixaggio.
Sei un perfezionista?
Ti rispondo così: ci sono dischi miei di anni ed anni fa che riascolto ed ancora adesso sto male ma veramente male perché un rullante lo cambierei, perché il mix non è stato fatto a modo, eccetera eccetera. Più volte, nel momento in cui era il caso di ristampare alcuni di questi dischi, avevo la tentazione di farlo sì, ma riaprendo il mix e di facendo quindi una ristampa con un mixaggio nuovo o con alcune parti cambiate. Anche solo una nota di chitarra, che suona troppo lunga al mio orecchio di ora, mi può far star male. O ancora: il nuovo disco con Hoshiko Yamane, violoncellista giapponese residente a Berlino e da anni membro fra le altre cose dei Tangerine Dream, è lì bello fatto, pronto, da almeno tre mesi. Ma non mi decido a chiuderlo. Continuo a cambiare dei microparticolari. “Hoshiko, scusa, ma ho cambiato il filtro di quel synth…”; e lei che è giapponese, quindi è ancora peggio di me, mi risponde “Certo, va bene. Però fallo due battute più in là”. Capisci quanto siamo terribili? (risate, NdI) Ma tutto questo mi porta via tempo, e non invece energia emotiva: perché la triste verità è che tutto questo in qualche maniera mi piace, mi soddisfa, è una sorta di masturbazione, una forma di piacere onanistico.
Un piacere prolungato. Lo accennavo prima: la tua discografia è veramente sconfinata, vastissima. Ne sei consapevole, comunque?
In parte sì. Ti spiego. Io ho da sempre una specie di “lista definitiva dei desideri” fin da quando ho iniziato a suonare, ok? Ovvero un elenco dei musicisti con cui mi piacerebbe fare qualcosa prima di schiattare. Una lista anche mutevole, eh: perché ad esempio all’inizio ai primissimi posti c’era Björk – impazzivo per lei, agli inizi della sua carriera – ed ora invece la trovo assolutamente insopportabile, non sopporto più come canta, non sopporto più la sua maledetta iperconcettualizzazione di qualsiasi cosa, non sopporto più i suoi vestiti del cazzo. La trovo clamorosamente circense, ma non nel modo circense “bello” e divertente degli Skipknot (che ancora oggi vado a sentire con gusto e mi diverto come un bambino): no, lei ormai mi dà proprio fastidio.
Chi l’ha rimpiazzata, nella tua “lista dei desideri”?
Sicuramente Lady Gaga. Sicuramente Billie Eilish, anche. Ecco, la Eilish: è la voce più bella che abbia sentito negli ultimi anni. Mi fa venire le lacrime, da quanto è brava ed espressiva. Sono molto legato alla sua musica, perché mia figlia la mette sempre nelle sue playlist. Assieme ai Sepultura…
Ai Sepultura?! Ma ha nove anni, tua figlia, se non sbaglio!
Certo. O al K-pop, infatti. O anche però ai Christian Death. Ultimamente ha preso ad ascoltarli, chissà come mai… (sorride, NdI)
I Christian Death sono colpa tua.
Può essere. Comunque, ripeto, la Eilish è eccezionale. Spero che non la rovinino; spero che la fama e il successo planetario non la schiaccino, come invece è avvenuto con Amy Winehouse, un’altra forza della natura. Ma tornando alla tua domanda: io effettivamente mi rendo conto di avere fatto abbastanza nella vita, come musicista, perché in realtà gran parte dei nomi in questi mia “lista” hanno già la spunta accanto. Prendi Harold Budd: per anni ho sognato di fare cose con lui.
Ed è andata a finire esattamente così.
Ma questo momento prima che arrivasse si è fatto attendere parecchio. Anche perché spesso spesso non c’erano le condizioni: non c’era il budget per proporgli alcunché. Perché vedi, io non ho praticamente mai avuto un manager: ho fatto un paio di tentativi, sì, ma ho lasciato perdere ben presto. E ti dirò, manco per colpa delle persone che avevo provato, perché io capisco che farmi da manager sia un inferno: io sono un artista che prima fa un disco come quello di Blackwood che è praticamente doom metal ed apocalisse e subito dopo è capace di farti il disco etereo ambient-jazz con Nils. Lo so che “piazzarmi”, così, diventa un incubo. Sta di fatto che tutto quello che ho fatto l’ho fatto perché sono uno che muove le chiappe ed alza il telefono, contatta le persone, le incontra… o perché sono le persone a cercare me, ad incontrarmi, a chiedermi di fare qualcosa assieme. Stop. Se poi ti racconto come ho conosciuto Bill Laswell, una delle persone fondamentali nella mia vita e nella mia carriera, capisci tutto. C’è anche un po’ da ridere.
(Già nel 1984, funk spaziale surreale; continua sotto)
Vai.
Era da un po’ che volevo contattarlo, Laswell: era chiaramente un maestro della “mia” musica e del “mio” approccio alla musica, un punto di riferimento assoluto per me. Ma io mi vedevo come artista di supernicchia, mica un genio in mille campi diversi come lui. Non solo, con quel provincialismo tipicamente italiano pensavo “Ma figurati se questo mi caga…”. Petulia un giorno è arrivata da me, e mi ha detto: “Abbiamo un fax in ufficio? Sì. Bene. Ora gli mandi un fax”. Mi ha convinto. Lo mando. Dopo due giorni mi arriva un fax di risposta del suo management – l’ho conservato, questo fax, scannerizzandolo – in cui si diceva “Bill è assolutamente interessato alle tue proposte, mettetevi direttamente in contatto”.
Eh…
Dopo due mesi abbiamo trovato il modo di incontrarci a Parigi, e da lì è partito un rapporto intensissimo e duraturo. Poi un’altra persona importante nella mia vita è Marco Pierini, che è un gigante della cultura italiana – ora ad esempio guida tutto il dipartimento museale dell’Umbria. Quando era a capo del Palazzo delle Papesse, a Siena, mi contattò dicendo “Voglio fare una mostra dove si ricrei un ambiente dalla libertà creativa sconfinata. Proponimi qualcosa”. Io gli chiesi il budget. Il budget c’era. Chiamai così Harold Budd, di cui anche lui era un grande fan, quindi perfetto, allineatissimi. Lì però mi disse: “Fantastico. Ma voglio che l’attrazione non siate voi due, l’attrazione deve essere prima di tutto la video installazione di Petulia. Voi dovete fare da colonna sonora al servizio di essa”. Capisci? Arrivarono poi altri progetti nati grazie all’impulso di Marco. Ad esempio uno con Giovanni Lindo Ferretti – anche di lui era grandissimo fan, e quello era tra l’altro il periodo in cui io e Giovanni collaboravamo parecchio – oppure, a Perugia, con Thomas Fehlmann.
Ecco: Ferretti, Fehlmann. Due personaggi “trasversali” rispetto a due mondi, quello del pop mainstream da un lato e dell’elettronica da club dall’altro, che anche tu hai sempre solo sfiorato ma mai realmente affrontato: non ci sei mai entrato dentro davvero. Eppure secondo me ti poteva capitare, di entrarci a pieno titolo, ed anzi per il tuo tipo di attitudine ti potrebbe capitare anche adesso.
Con il sistema industriale del pop ho avuto a che fare soprattutto quando ancora vivevo a Milano. Facevo un mare di remix per artisti delle major. Era un periodo che se non facevi uscire pure un disco di remix oltre a quello “normale”, beh, non eri nessuno… Mi sono anche trovato nel ruolo di produttore, ad esempio con gli Acid Folk Alleanza, che se vuoi rispetto al pop erano magari un po’ borderline, perché il loro era un pop colto, pieno di citazioni, con testi particolarmente di qualità (Taver è un grandissimo autore, davvero intelligente); e poi come produttore ovviamente nella parte finale, nella catastrofica parte finale del sodalizio tra Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, il cui figlio indiretto poi è stato “Co.Dex” di Giovanni. Quella situazione lì me la sono vissuta quasi sbroccando, perché non era davvero facile, credimi. Ma io con Giovanni comunque rifarei anche altri cinquanta dischi. Perché a prescindere dalle sue boutade – le chiamo così – che non mi appartengono, o meglio, mi appartengono quando parla di montagna e cavalli ma non quando gli parte l’embolo vaticanista-meloniano, ecco, a prescindere da quelle lui resta un autore incredibile, uno che è in grado di condensare in dieci parole concetti veramente profondi e complessi. E questo se vuoi è molto pop. Comunque sì, il pop di un certo tipo l’ho sfiorato più volte. Ad un certo punto anzi ci fu un’idea molto bella di Roberto Vernetti, che aveva creato un pool di produttori di cui facevo parte anche io.
Ecco, per me Vernetti è il simbolo della prima, vera fase di cambiamento del pop italiano. “Luce” di Elisa, ad esempio. Il pop di casa nostra che scopre alcune soluzioni bristoliane super-raffinate: chi l’avrebbe mai detto. Fino a un attimo prima…
…il pop di casa nostra era solo una roba di un kitsch inaudito, già. E negli anni ’90 ad un certo punto sembrava che le cose potessero cambiare, hai ragione.
Sono cambiate?
Mica tanto. Se guardi oggi Sanremo qualcosa di interessante c’è, ma il grosso ancora adesso è prodotto in modo tale che la voce è lì, altissima, troneggia su tutto, e sotto invece c’è come un’unica barra, un unico “mattone” dove sono conficcati dentro undici, dodici layer di pura merda plastificata. Bisognerebbe invece capire che se hai fra le mani un cantante bravo, e intendo uno bravo davvero, non un gioppino alla Achille Lauro che sta lì a fare spettacolo, non hai bisogno di tutto questo, non è l’unica formula possibile: e di interpreti bravi pure in Italia ce ne stanno. All’estero lo hanno capito da tempo. All’estero sono molto meno legati ai cliché, molto meno tradizionalisti e molto più invece costantemente disposti ad innovare, a sperimentare, anche per quanto riguarda il pop.
Però dai, ci stiamo arrivando un po’ anche in Italia.
Io credo che la trap, pur con tutti i suoi limiti, abbia dato una sberla molto salutare al panorama sonoro italiano. Comunque sì, a me col pop piace misurarmi. L’ho imparato ai tempi dei Prozac +. Un gruppo che all’epoca detestavo, me li spacciavano per “punk” ed io inorridivo, “Ma punk cosa, questi fanno solo canzonette pop…”. Un giorno mi arrivò una committenza: remixarli. Io all’inizio dissi “No. Non ci penso nemmeno, mi fanno cagare”. Infine cedetti e, accidenti, mi divertii moltissimo. Perché “entrando” nel loro materiale capii che era comunque pop fatto benissimo, con armonie notevoli, arrangiamenti perfetti. Sai, da giovane ero molto più oltranzista; col tempo, ho smussato gli angoli.
(il progetto Charged, assieme a Toshinori Kondo e Bill Laswell, più ospiti vari; continua sotto)
E poi c’è l’elettronica da club, da dancefloor.
Che mi interessa un sacco, in realtà. E da sempre. Anche lì, ovviamente ho le mie predilezioni: ci sono cose che trovo agghiaccianti, e poi ci sono invece artisti che adoro. Uno di questi è Plastikman, Richie Hawtin. Per me è un genio assoluto. Non lo si direbbe mai, ma un personaggio che gli associo è Robert Miles. Di cui nel tempo era diventato amico, quindi posso dire di averlo conosciuto bene.
Che tutti conoscono come autore di “Children”, ma in realtà era un musicista sfaccettato, con un sacco di amore per la jazz-fusion più irregolare, per certe cose world.
Roberto mi contattò perché voleva un mio remix. Glielo feci, glielo mandai. Era una roba drum’n’bass. Rimasi colpito dalla sua onestà: perché dopo qualche giorno mi rispose “Eraldo, la traccia è perfetta, suona benissimo, è un ottimo lavoro, ma – non mi piace. Non ti offendere, ma non la metterò nel disco di remix. Naturalmente però ti pagherò esattamente quanto ti spetta” (…che per inciso, non era manco poco: venni pagato molto bene per quel lavoro). Da lì la stima reciproca è diventata veramente forte. Tant’è che gli chiesi di fare lui un remix per me, sul materiale di Charged. Il problema è che per questa operazione la R&S aveva messo un budget davvero ridicolo, potevo permettermi davvero una miseria, ma per Robert non ci furono problemi. Tornando comunque in generale al mio rapporto col mondo della musica da club, beh, è strano. Ogni tanto ci finisco dentro quasi per caso. Ad esempio, non so nemmeno io perché ma in Giappone mi è capitato di fare un tour da solista accompagnato di volta in volta da amici dj dove alla fine si è suonato un sacco di dub-techno. Però ecco, in generale è un mondo molto specifico, con delle sue regole, come giusto: però proprio per questo motivo non sempre fa per me. Per dire, non per forza se faccio una roba di impianto techno deve esserci la cassa, la 909, nel “mio” mondo musicale: ma capisco invece che la musica da club abbia le sue regole, e le rispetto. Ci sta che le abbia, davvero, e che pretenda siano rispettate. Poi se vuoi anche il mio progetto SIMM prende un po’ da quel mondo, l’ultimo album è… boh, dubstep? Dark dub? Dark hip hop? Al solito quando entrano in campo le definizioni, è difficile. C’è una cosa comunque che mi piace molto della musica da club: ed è il fatto che lavori molto con la gioia e l’euforia delle persone. Ha insomma una dimensione quasi rituale – e come puoi immaginare se conosci la mia discografia sai che la dimensione rituale per me è un pilastro assoluto.
Assolutamente sì.
Io vengo dal punk e dal metal, non vengo dalla composizione. Non sono uno di quelli che se vede uno spartito di Mozart gli viene un’erezione, perché “…guarda che capolavoro di armonia, che scrittura”. Ovvio, capisco che è musica splendida, ma per me uno spartito è solo un interessante manufatto grafico, per me la musica si costruisce sulle emozioni, non sulle note. Prendi il primo EP dei Discharge: due accordi, sei parole, ma ancora oggi a livello emozionale mi dà una sberla pazzesca. O ancora, il primo Eno ambient: tre note, dei droni, nient’altro, eppure ti si apre un mondo emotivo pazzesco quando lo ascolti, ancora oggi. Per questo la musica della club culture mi interessa parecchio: ha sempre una dimensione ancestrale, che si basa su una specie di energia atavica, che è come quella dei rituali – una dimensione che appunto mi interessa da sempre tantissimo, basta vedere quanto ho fatto negli anni. Appunto: energia, la chiave è lì. Per intenderci, se parliamo di elettronica robe come gli Air mi fanno cagare mentre Dasha Rush mi piace un sacco. E poi c’è Jeff Mills: ecco, lui è un mio idolo assoluto. Uno in grado di passare dal funk alla techno fino addirittura alle collaborazioni con orchestre sinfoniche, mantenendo sempre il suo rigore, sempre la sua identità, con un piglio quasi ieratico: è come una divinità, lui. Sì: come Dio, Jeff c’è.
Foto di Michele Turriani