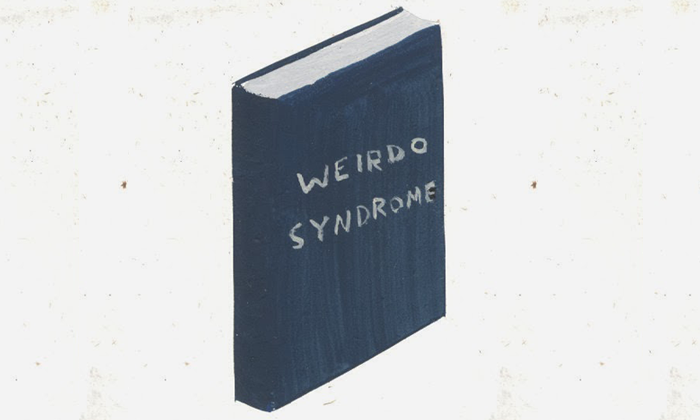Certo che il web è proprio strano. Lo diventa ogni giorno sempre di più, in quanto universo in costante espansione, che accoglie continuamente nuovi attori e quindi nuove visioni e che abbatte via via nuove barriere tematiche o tabù. Produce ogni giorno migliaia di nuove pagine e giorno per giorno il gioco è vedere quanto alcune siano spiazzanti, inafferrabili, a volte quasi incomprensibili. Spesso queste cose le leggiamo sul momento, ci riflettiamo su un paio di minuti e ce ne dimentichiamo rapidamente. Oggi invece su #crumbs ci torniamo su, riprendendo gli articoli musicali più controversi apparsi nel web nelle ultime settimane. È il nostro modo di misurare la temperatura di internet oggi, sapere dove siamo e a cosa stiamo andando incontro. Giusto per capire se sta per arrivare il giorno in cui ci condurranno dallo psichiatra, o se è il web che mostra sintomi di psicosi.
[title subtitle=”Il fascismo alla Blackest Ever Black (un titoletto tranquillo)”][/title]
Questo strano articolo è apparso pochi giorni fa sul blog personale di Josh Hall, giornalista che scrive solitamente per RA, FactMag, The Quietus e diversi altri importanti magazine internazionali, ma che stavolta si affretta subito a sottolineare come nessuno abbia voluto pubblicare lo scritto in questione. Che il tema non sia esattamente leggero lo si capisce fin dal titolo: “Fascismo e colonialismo nella musica di Cut Hands e Blackest Ever Black“. Il testo parte con una critica piuttosto energica alla musica di William Bennett e al carattere vagamente razzista del suo uso dei suoni africani, poi prosegue elencando una serie di prove che testimoniano le simpatie di estrema destra di alcuni artisti noise dell’area Blackest Ever Black e infine conclude dichiarando inaccettabile questo “neo-colonialismo” che sta infettando certa techno recente. Accuse piuttosto pesanti, rivolte più alle persone che alla loro musica, che ovviamente han fatto arrabbiare i fan della BEB (con reazioni – tutto sommato condivisibili – circa la gratuità del mettere in cattiva luce certa musica screditando chi la produce) e che fan venire un leggero sospetto che dietro a tutto questo ci sia una battaglia personale da parte di chi ha scritto il pezzo. Vengono in mente tante domande: ha senso chiedersi quali siano le fedi politiche o religiose di chi produce la musica che ci piace (o che non ci piace)? Dovremmo cambiare il nostro apprezzamento in base a quello? C’è qualcosa di pernicioso che tale musica sta trasmettendo al mondo? E su tutte: è davvero importante rispondere a tali domande? Noi opteremo per un profilo rassicurante: lasciamo che altrove dipanino la matassa e continuiamo a godere della marzialità autoritaria di certa techno senza preoccuparci troppo. Anche se a volte fa spuntare le fiamme dell’inferno (anzi, magari il bello è proprio quello).
[title subtitle=”La deportazione di Wiley in diretta twitter (perché Fact sa cosa vuole il pubblico)”][/title]
Dopo l’articolo di cui sopra, uno giustamente esclama “ammazza che accollo” (scusate il romanesco), “ma non c’è niente di più easy?”. Gira un po’ e viene accontentato subito, con un altro curioso pezzo pubblicato proprio in questi giorni da Fact: a quanto pare il povero Wiley è stato prelevato con la forza dalla polizia locale canadese e rimpatriato al proprio paese d’origine. Sbagliando pure la mira di qualche chilometro, perché invece che a Londra è finito in Scozia. E sapendo quanto il rapper britannico è solitamente attivo su twitter, potete immaginare la sfilza di improperi e parolacce improvvisata sul suo profilo, con tanto di ironia tagliente sulla colazione scozzese a base di quadrati di salsiccia. I quadrati di salsiccia, capite? Ora noi saremo cinici, ma ci viene in mente la redazione di FactMag che prima cassa il pezzo sul fascismo techno dicendo “non scherziamo, troppo pesante” e poi scoppia in un applauso fragoroso sulla bozza di Wiley, all’urlo di “è questo che vuole la gente!“. Stranezze del giornalismo 2.0. Nel frattempo Wiley se la ride e chiama il taxi. “Scusate, ho lasciato il passaporto in Canada…”
[title subtitle=”Elegia del tecnicismo giornalistico (il web degenerato)”][/title]
Poi ci sta che uno si incazza. Si incazza e pubblica una requisitoria cattivissima sul web e sul giornalismo musicale attuale, che ormai è tutto “lifestyle” e niente analisi tecnico/critica. Un lamento che ha vari aspetti condivisibili eh, sia chiaro. Quando però noti che è pubblicato sul Daily Beast, magazine di politics, fashion e entertainment, senti che qualcosa non va. Al che ti informi meglio su chi è l’autore di tale capolavoro di coerenza: è lui, Ted Gioia, jazzista, scrittore, storico della musica e autore di diversi libri e dell’enciclopedia del jazz. È lì che per magia l’articolo assume connotati diversi e diventa il lamento definitivo di un cinquantenne disperato, che non si riconosce nei tempi di internet e rimpiange il proprio passato, condannando indirettamente i lettori moderni (dove “moderni” significa da Lester Bangs in avanti) di dar seguito a una stampa poco tecnica e molto di intrattenimento. Solo che lo scrive nel web, perché se ci scrivesse su un libro lo leggerebbero in dieci, parenti compresi. Ehi Ted, il sistema contro cui ti scagli è lo stesso a cui chiedi attenzione! Non sarà un po’ troppo semplicistico salire sul piedistallo e dare a tutti degli scemi? Qui pensiamo che le cose siano un tantino più elaborate, una visione più estesa e realistica te l’han data su Popmatters e a noi è piaciuta un sacco la loro osservazione circa il fatto che, beh, “discutere delle scale usate dagli Arcade Fire non è esattamente il modo migliore per cogliere l’essenza della loro musica“. C’è vita oltre al tecnicismo.
[title subtitle=”L’unità di misura dell’hipsteria (le vecchie, sane prese in giro)”][/title]
Poi ti sovviene l’altra possibile risposta da dare all’articolo precedente: “ehi capo, l’intrattenimento tira anche perché, su, siamo nel web, siam qui per svagarci cinque minuti“. Argomentazione inattaccabile. Si studia e si lavora tutto il giorno, quando siam qui una risata non la disdegniamo. E qualche tempo fa è stato il pezzo di Priceonomics sull’“indice di hipsteria in musica” a farci ridere parecchio. O meglio, più del pezzo in sé è stato esilarante osservare le reazioni dei veri hipster nel leggerlo. L’articolo è fondamentalmente una sorta di ricerca scientifica atta a prendere in giro i luoghi comuni a loro legati, partendo da due presupposti fondamentali: 1) l’hipster è tale se apprezza musica sconosciuta ai più e 2) Pitchfork resta il riferimento stabile per i loro ascolti. Combinando le due cose nascono diverse contraddizioni, visto che spesso P4K spinge nomi molto popolari (quindi incompatibili con lo spirito hipster). Misurando il “tasso mainstream” di un artista in base al successo facebook ne vien fuori la distribuzione grafica raffigurata nell’articolo e alcune considerazioni di rilievo: ehi ragazzi, apprezzare Kanye West, Daft Punk o Justin Timberlake non fa hipster! Restano invece entro i margini di sicurezza nomi come The Field, Julia Holter e Burial, almeno per ora. Ma alla fine il vero indice di hipsteria si misura in base a quanto l’interlocutore si stizzisce su queste ironie. Se risponde piccato qualcosa tipo “umpf, che analisi stupida“, significa che è cotto. E allora voi rispondete canzonando i Vampire Weekend (la peggio cosa prodotta dalla cultura hipster negli ultimi anni, ma forse non è il caso di dirglielo).
[title subtitle=”La ricerca dell’underground dai Sex Pistols a Skrillex (mira alla pancia e vai sul sicuro)”][/title]
Tra noi elettronici, invece, la personalità che più si avvicina agli hipster è il cosiddetto missionario dell’underground. L’inseguimento della genuinità musicale in quel caso passa per la ricerca di quel tesoro perduto che è la produzione dal basso, l’attitudine elitaria e tutti quei caratteri misteriosi che ai tempi di internet occorre chiarire per bene, discutendo, ragionando e lanciandosi in ardite interpretazioni di cosa underground significhi oggi. L’ultima di queste appassionate elucubrazioni ce l’ha offerta questo articolo apparso su un blog italiano: una cosetta easy di 30000 battute che parte dai Sex Pistols, continua con la tendenza dei club a proporre artisti che fanno soldout, sfiora le teorie no global del boicottaggio del marchio capitalista, intervista due produttori nostrani sul concetto di underground e chiude spiegando che sì, ci stan prendendo tutti in giro, ma il nostro potere d’acquisto può cambiare ogni cosa. Il tutto sottolineando prontamente ogni dieci righe che “oh, lo so, non vi sto dicendo assolutamente nulla di nuovo“. Eppure cacchio se è piaciuto, condivisioni di massa e complimenti sul “concetto espresso in modo chiarissimo” che si sprecano. Perché lo sfogo catartico è la nuova frontiera della fruizione giornalistica e, ai tempi in cui Grillo e i cinquestelle scoprono il vaso di Pandora nel dare finalmente risonanza alla protesta di pancia (anche quando essa produce ricette note o non ne produce affatto), il risultato è che questo, oggi, è quanto di più prossimo al giornalismo di massa. Già, proprio quello che insegue con insistenza l’idea di underground, per assurdo. E nel frattempo, altrove c’è un’altra massa, ben più ampia ma meno orientata alla lettura, che di tutto questo se ne sbatte, bassa le estati a Ibiza e ascolta quello Skrillex i cui effetti spaventano tutti. E pensare che la sua sola colpa è aver spinto una svolta estetica che, toh, ha portato la sua musica alla diffusione di massa. Il modo più facile per attirare l’odio di mezzo mondo, di questi tempi.