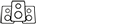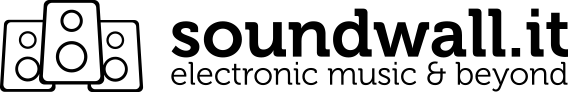Ha fatto molto rumore, il coup de theatre di Pierangelo Buttafuoco, il da poco eletto Presidente della Biennale di Venezia, dello scegliere Caterina Barbieri come direttrice artistica per le prossime due edizioni della Biennale Musica. Poi in realtà poteva andarci persino peggio – o meglio, a seconda dei punti di vista – dato che pareva che la prima scelta per la direzione artistica fosse in realtà Giovanni Lindo Ferretti… Pare però lui abbia preferito la vita tranquilla tra i cavalli appenninici, più qualche comparsata in giro (vediamo se la risurrezione dei CCCP avrà altri seguito, o se è stato raccolto il raccoglibile), niente sbatti del costruire un programma per la Biennale Musica, con conseguente necessità di trovare al volo un’alternativa a lui. Invece di scegliere la via tranquilla di una scelta nel novero della classica contemporanea, senza velleità di scompaginamento, una volta esauritasi la fiammeggiante pista GLF Buttafuoco non ha voluto invece deviare dalla strategia del coniglio-dal-cilindro. Ci teneva troppo a lasciare un segno, tra genio e sberleffo, evidentemente.
Sia come sia, noialtri abbiamo salutato con gioia e soddisfazione la scelta di Caterina Barbieri: non solo e non tanto perché è una dei “nostri”, musicalmente parlando, ma soprattutto perché è seria, preparata, affermata internazionalmente, ed è stata pure più forte dei soliti rumours idioti che accompagnano quasi qualsiasi donna che ha il “torto” di primeggiare in ambiti solitamente maschili. Perché sì, siamo messi ancora così. Siamo messi così anche negli ecosistemi musicali che dovrebbero essere invece un po’ più evoluti rispetto ai cercopitechi, o ai film con Lando Buzzanca.
Siamo ancora messi, tra l’altro, che in certi ambienti della musica colta si disquisisca sulla “povertà espressiva” della musica della Barbieri, che avrebbe il torto di non essere abbastanza sperimentale, abbastanza articolata, abbastanza ostica, abbastanza intellettualmente attorcigliata/elaborata su se stessa, il torto insomma di essere troppo compiacente, musicalmente parlando. Sono bellissime, queste critiche: perché non lo sanno, ma sono la perfetta cronaca del perché la musica classica contemporanea abbia perso e stia perdendo progressivamente presa sulle persone in tutto l’ultimo secolo. Nel momento in cui l’elitarietà e l’osticità si fanno valore, un valore superiore rispetto a tutto e tutti, si mette la firma su un destino fatto di autoreferenzialità e, oh sì, progressivo declino. Ovvio che le musiche più difficili e più complesse vanno difese, vanno portate avanti, hanno qualità profonde se sviluppate a modo, sono anzi addirittura una necessità per non finire solo ad ascoltare roba “pigra”, che non richieda uno sforzo interpretativo; tutto questo è sacrosanto; ma la difesa aprioristica e senza mediazioni del “fortino” della musica colta fa male prima di tutto alla musica colta stessa, che smette di misurarsi col mondo e si misura semmai solo con sé, solo con una nicchia sempre più anagraficamente vecchia, sempre più intellettualmente spenta. L’ultima cosa che auguriamo alla musica classica contemporanea è di essere attaccata al respiratore artificiale delle istituzioni e delle fondazioni, come unica soluzione. Già accade troppo spesso, per inciso.
(Caterina Barbieri in azione: da musicista, non da direttrice artistica; continua sotto)

Anche per questi motivi abbiamo salutato con gioia la nomina di Caterina Barbieri: un’artista viva, abituata a misurarsi col pubblico e col mercato, pur avendo comunque una solida preparazione teorica in quanto a Conservatori ed Accademie (ci è passata, ma non è “rimasta lì”). Come abbiamo detto più volte, vogliamo troppo bene alla Biennale Musica – che reputiamo un patrimonio in primis proprio perché fa da culla e proscenio a molti momenti preziosi espressi dalla classica contemporanea dal ‘900 ad oggi – per accettare che essa diventi un corpo estraneo rispetto al presente, e serva solo come capsula di protezione per il “panda” della musica colta/classica, un panda seguito ed accudito da un numero decrescente di adepti (qualcuno convinto e preparato, ovviamente ce ne sono, qualcuno però adepto solo perché un po’ di decenni fa andare a sentire la classica “faceva prestigio”, e pensano sia ancora così). E tutto questo lo affermiamo perché in praticamente due decenni di frequentazione assidua della Biennale abbiamo visto delle cose altamente interessanti, talora proprio folgoranti, e in generale spesso è più creativamente stimolante l’ambiente della musica colta di quello – stantìo, ma collaudato e fruttifero – della musica elettronica in chiave techno e house. Non è insomma questione di schierarsi “O di qua” (fra i “nuovisti”), “O di là” (fra i custodi dello status quo più rigoroso). È importante capire che contano più i dialoghi e i ponti degli schieramenti. Questo è il punto.
Una delle critiche “da sinistra” che abbiamo letto in giro dopo l’uscita dei primi nomi messi in cartellone dalla Barbieri è una critica interessante: riassumendo, con le scelte perseguite la Biennale perde la sua specificità e diventa “un Atonal o un CTM qualunque”. Capiamo che Actress e Suzanne Ciani, Elysia Crampton, William Basinski, Christian Fennesz, Moritz Von Oswald, volendo anche Laurie Spiegel, Graindelavoix e Defforrest Brown Jr. possano essere “letti” in tal senso, sanno di intellettualità, Currywurst, Ampelmann, Kraftwerk nel senso dell’edificio sulla Sprea, Kantine, CTM e pensosi vestiti neri. Però forse la specificità è proprio portare questi nomi lì dove di solito non vanno, dove mai sono stati o quasi, ovvero nel “salotto buono” della Biennale veneziana, e vedere l’effetto che fa. Chiaro che Caterina Barbieri porta il suo mondo, e il suo mondo è molto più vicino all’Atonal che alla programmazione “colta” di Radio Rai Tre; è altrettanto chiaro che la sua proposta non sorprende, non spiazza, non “detona”, e porta la Biennale in un solco già tracciato da altri (anche il Mutek, per dire, o un Sónar diurno, o molti altri ancora, oltre a quelli già citati). Ma è davvero così drammatico che per un paio di edizioni la Biennale Musica assomigli un po’ di più al Mutek o all’Unsound? Perché non provare a vedere cosa questa scelta – una scelta “pop”, a livello di musica di ricerca – possa invece generare, a livello di impatto su pubblico, critica, città, curiosi, simpatizzanti, semplici passanti? Tanto più che ci sono delle commissioni specifiche (Basinski, Crampton), delle prime europee (Spiegel) o italiane (l’improbabile duo Actress/Ciani, Moritz Von Oswald col suo nuovo progetto), insomma, non è solo prendere le cose giù dal catalogo delle agenzie e spedire la proposta di contratto +++ (…questa la capiscono gli addetti ai lavori, ok). Al massimo lo è “mossa facile” in quanto a business del booking la bizzarra scelta di un dj set di Carl Craig: ma in realtà noi siamo qua a sperare che un contesto così particolare possa spingere Craig a tornare finalmente ad essere interessante e sfidante, non a fare il compitino, come invece – soprattutto da dj – sta facendo da vent’anni a questa parte. E se fosse lui, a sorpresa, il vero valore aggiunto, il vero “scarto” rispetto al prevedibile?
Altri annunci sono in arrivo, il cartellone della Biennale Musica 2025 non è ancora completato. Se quanto uscito finora non sorprende o non spiazza, non per questo però è da considerare a priori di scarso valore o, peggio ancora, inutile. Del resto siamo ancora qua a parlare della Biennale Musica di Uri Caine, ormai oltre due decenni fa, una scossa molto contestata all’epoca ma alla prova dei fatti molto salutare: anche quella era una Biennale ritagliata a sua immagine e somiglianza, c’era molto della sua “comfort zone”. Eppure, siamo ancora vivi. Ed è ancora viva la Biennale. Che anzi, senza quello scossone ora starebbe probabilmente molto peggio di come sta, molto più malata e thomasmanniana – e noi invece la vogliamo in salute, per altri cento anni ed edizioni ancora. Con un bel currywurst basic-channelliano una tantum, metti mai che Tadzio ripigli colore ed entusiasmo, invece di estanuarsi ed astrarsi come se fosse l’unica cosa possibile da fare, come se fosse l’unico suo destino. Anche se è vero: presentare questa Biennale proprio a Berlino è come raccontare Napoli con pizza, speghetti e mandolino, o Roma coi finti legionari davanti ai Fori Imperiali. Sarà anche successo per comodità/necessità logistico istituzionali, ma… si poteva evitare.