Nei primi anni Ottanta nasce un nuovo stile musicale frutto della collisione tra generi diversi, l’electrofunk. Tra i capostipiti di questo filone, fondamentale per la techno che fiorirà qualche tempo dopo, c’è Man Parrish, passato di diritto alla storia con brani come “Hip Hop, Be Bop (Don’t Stop)”, “Boogie Down (Bronx)” ed “Hey There, Home Boys” che ispirano più di una generazione attraverso un suono che mette in relazione musica bianca e nera. Parrish, nel suo studio amatoriale a New York, distilla il pfunk di George Clinton e le androidizzazioni dei Kraftwerk facendo passare il risultato nelle maglie di un suono dotato di ingranaggi meccanici in cui trova spazio pure una forma primitiva di hip hop. Problemi sorti prima con l’etichetta e poi col manager gli impediscono di godersi appieno il successo e la sua storia finisce col diventare un monito per chi si avvicina incautamente al business discografico. Nel 1986 produce l’album dei Man 2 Man trainato dalla hit hi-NRG “Male Stripper” e poi si dedica all’attività manageriale per artisti come Village People e Crystal Waters. Defilato dalla scena mainstream ma tra i primi nomi menzionati quando si parla dell’hip hop robotico di Afrika Bambaataa, Hashim, Egyptian Lover, Newcleus, Imperial Brothers, Jamie Jupitor o The Jonzun Crew, Man Parrish sta per tornare con un nuovo album, il quarto di una carriera che in trentacinque anni gli ha regalato gioie e dolori.

La tua carriera discografica inizia ufficialmente nel 1982 con la pubblicazione di “Hip Hop, Be Bop (Don’t Stop)”, ma so che registrasti qualcosa, in modo del tutto amatoriale, già negli anni Settanta, quando ascoltavi John Cage e Karlheinz Stockhausen.
Entrai in contatto con quel tipo di musica grazie alla marijuana, negli anni Settanta mi facevo un sacco di canne. Mi autocostruii il primo sintetizzatore in una semplice scatola e trascorrevo ore a girare manopole creando suoni stranissimi e riversando poi il risultato su nastri registrati con un vecchio tape recorder. Ascoltando oggi quella musica la chiameremmo semplicemente “ambient” ma ai tempi preferivo identificarla come “sound sculptures” perché il termine “ambient” non era stato ancora inventato. Quando scoprii Cage, Stockhausen ed altri artisti sperimentali di quel tipo mi sentii spronato a creare musica pur non essendo un musicista. Non sapevo scrivere o leggere lo spartito ed ero del tutto a secco di teoria musicale. La sperimentazione ha tenuto vivo il mio interesse in tutti questi anni, più di quaranta ormai.
In che modo riuscisti ad ottenere il tuo primo contratto discografico con la Importe/12 Records, sublabel della Sugarscoop?
 Mi occupai della colonna sonora di un film porno chiamato “Heatstroke”. Non lo vidi nemmeno ma mi offrirono mille dollari in cambio di una serie di brani da tagliare ed usare come sonorizzazione della pellicola. Ero giovane e particolarmente squattrinato, l’idea di incassare ben mille dollari per così poco mi allettò parecchio perché pensavo di poter diventare ricco. Poi accadde qualcosa di totalmente inaspettato. Un DJ, Lance Weiss, stampò la colonna sonora del film su un test pressing in vinile ricavandola direttamente dalla videocassetta Betamax, e la suonò nel club in cui lavorava. Il caso volle che lì, al The Anvil di New York, ci fosse anche un mio amico che il giorno dopo mi riferì tutto. L’Anvil era un locale particolarmente noto in città per drag queen mangiafuoco e spettacoli sexy. Ero felice che la mia musica fosse stata suonata in un posto simile e la sera seguente mi recai lì di persona per verificare se la cosa fosse vera. Mentre ero imbambolato di fronte alle cose pazzesche che vedevo, improvvisamente partì un mio pezzo. Corsi nella cabina del DJ e gli dissi a gran voce «hey, questo è il mio disco!». Mi rispose che c’era una casa discografica interessata a pubblicare la mia musica e che il giorno dopo mi avrebbe accompagnato personalmente nella sede. Così, poco dopo, firmai il contratto con la Importe/12 Records.
Mi occupai della colonna sonora di un film porno chiamato “Heatstroke”. Non lo vidi nemmeno ma mi offrirono mille dollari in cambio di una serie di brani da tagliare ed usare come sonorizzazione della pellicola. Ero giovane e particolarmente squattrinato, l’idea di incassare ben mille dollari per così poco mi allettò parecchio perché pensavo di poter diventare ricco. Poi accadde qualcosa di totalmente inaspettato. Un DJ, Lance Weiss, stampò la colonna sonora del film su un test pressing in vinile ricavandola direttamente dalla videocassetta Betamax, e la suonò nel club in cui lavorava. Il caso volle che lì, al The Anvil di New York, ci fosse anche un mio amico che il giorno dopo mi riferì tutto. L’Anvil era un locale particolarmente noto in città per drag queen mangiafuoco e spettacoli sexy. Ero felice che la mia musica fosse stata suonata in un posto simile e la sera seguente mi recai lì di persona per verificare se la cosa fosse vera. Mentre ero imbambolato di fronte alle cose pazzesche che vedevo, improvvisamente partì un mio pezzo. Corsi nella cabina del DJ e gli dissi a gran voce «hey, questo è il mio disco!». Mi rispose che c’era una casa discografica interessata a pubblicare la mia musica e che il giorno dopo mi avrebbe accompagnato personalmente nella sede. Così, poco dopo, firmai il contratto con la Importe/12 Records.
Come ricordi la scena elettronica dei tempi?
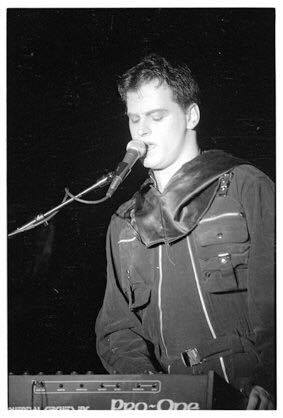 Non esisteva ancora una scena elettronica. Fondamentalmente c’era il rock n roll con le chitarre, il jazz, la musica classica e le prime cose punk e new wave. L’unica maniera per ascoltare qualcosa di elettronico era puntare ad album come quelli dei Pink Floyd che però erano più vicini al concetto di “space music”, così come veniva identificata allora. Keith Emerson degli Emerson, Lake & Palmer e pochi altri iniziavano ad inserire assoli di sintetizzatore all’interno dei loro album rock. C’erano anche diversi dischi sperimentali come “Zero Time” ed “It’s About Time” dei Tonto’s Expanding Head Band o “Cosmic Furnace” di Roger Powell in cui si faceva largo uso del suono dei sintetizzatori, ma si trattava di dischi difficili da trovare e sconosciuti ai più. Quando uscì “Autobahn” dei Kraftwerk invece, anche le radio che solitamente programmavano esclusivamente rock iniziarono a trasmetterlo e fu letteralmente uno shock. Io avevo già un sintetizzatore e capii che avrei potuto sostituire una band intera usando solo quello strumento.
Non esisteva ancora una scena elettronica. Fondamentalmente c’era il rock n roll con le chitarre, il jazz, la musica classica e le prime cose punk e new wave. L’unica maniera per ascoltare qualcosa di elettronico era puntare ad album come quelli dei Pink Floyd che però erano più vicini al concetto di “space music”, così come veniva identificata allora. Keith Emerson degli Emerson, Lake & Palmer e pochi altri iniziavano ad inserire assoli di sintetizzatore all’interno dei loro album rock. C’erano anche diversi dischi sperimentali come “Zero Time” ed “It’s About Time” dei Tonto’s Expanding Head Band o “Cosmic Furnace” di Roger Powell in cui si faceva largo uso del suono dei sintetizzatori, ma si trattava di dischi difficili da trovare e sconosciuti ai più. Quando uscì “Autobahn” dei Kraftwerk invece, anche le radio che solitamente programmavano esclusivamente rock iniziarono a trasmetterlo e fu letteralmente uno shock. Io avevo già un sintetizzatore e capii che avrei potuto sostituire una band intera usando solo quello strumento.
“Hip Hop, Be Bop (Don’t Stop)” è considerato uno dei pezzi seminali per la musica electro. Come iniziasti a collaborare con John Robie e col compianto Raul A. Rodriguez menzionati come co-autori del brano?
 Registrai la traccia a Brooklyn nel mio bedroom studio, così come avvenne per gli altri pezzi che cedetti alla Importe/12 Records. Raul lavorava per l’etichetta occupandosi dell’edit delle canzoni insieme a vari DJ. Il proprietario della label (Mike Wilkinson, passato a miglior vita nel 1986, nda) non sapeva granché sul processo di produzione musicale così chiese a lui di supervisionare ciò che stavo facendo. In breve tempo diventammo grandi amici e lavorammo insieme a parecchi dischi. Qualcuno arrivò persino a dire che eravamo tanto legati da sembrare le Two Sisters (pure loro nel roster della Sugarscoop, nda) e su quell’affermazione creammo il progetto RaMa usando le iniziali dei nostri nomi ossia Raul e Manny. Mettemmo su pure gli I.R.T. (Interboro Rhythm Team), quelli di “Watch The Closing Doors!”, e i C.O.D. con “In The Bottle” (creata sul testo di “The Bottle” di Gil Scott-Heron, nda). Optammo ironicamente per C.O.D. (acronimo di Cash On Delivery) per rimarcare il nostro desiderio di essere pagati alla consegna del master in quanto era assai frequente che le famigerate case discografiche non riconoscessero denaro ai musicisti e ai produttori. John Robie invece fu coinvolto come musicista turnista. A mia insaputa l’etichetta strinse un accordo con lui promettendogli un terzo dei diritti in cambio della sua presenza in studio per poche ore. Ai tempi non sapevo nulla di publishing, copyright e questo genere di cose. Sono onorato e riconoscente a Robie per aver contribuito alla realizzazione del mio disco ma credo che cedergli, senza nemmeno chiedere la mia opinione, un terzo dei proventi oltre a menzionarlo come co-autore nei crediti, sia stato troppo. Come riconoscimento per la session da turnista sarebbero stati sufficienti poche centinaia di dollari. Comunque sono trascorsi trentacinque anni e non nutro alcun rancore nei suoi confronti ma ci tengo a precisare che nessuno di noi ha mai ricevuto un solo centesimo per quel disco, quindi praticamente abbiamo lavorato tutti gratis.
Registrai la traccia a Brooklyn nel mio bedroom studio, così come avvenne per gli altri pezzi che cedetti alla Importe/12 Records. Raul lavorava per l’etichetta occupandosi dell’edit delle canzoni insieme a vari DJ. Il proprietario della label (Mike Wilkinson, passato a miglior vita nel 1986, nda) non sapeva granché sul processo di produzione musicale così chiese a lui di supervisionare ciò che stavo facendo. In breve tempo diventammo grandi amici e lavorammo insieme a parecchi dischi. Qualcuno arrivò persino a dire che eravamo tanto legati da sembrare le Two Sisters (pure loro nel roster della Sugarscoop, nda) e su quell’affermazione creammo il progetto RaMa usando le iniziali dei nostri nomi ossia Raul e Manny. Mettemmo su pure gli I.R.T. (Interboro Rhythm Team), quelli di “Watch The Closing Doors!”, e i C.O.D. con “In The Bottle” (creata sul testo di “The Bottle” di Gil Scott-Heron, nda). Optammo ironicamente per C.O.D. (acronimo di Cash On Delivery) per rimarcare il nostro desiderio di essere pagati alla consegna del master in quanto era assai frequente che le famigerate case discografiche non riconoscessero denaro ai musicisti e ai produttori. John Robie invece fu coinvolto come musicista turnista. A mia insaputa l’etichetta strinse un accordo con lui promettendogli un terzo dei diritti in cambio della sua presenza in studio per poche ore. Ai tempi non sapevo nulla di publishing, copyright e questo genere di cose. Sono onorato e riconoscente a Robie per aver contribuito alla realizzazione del mio disco ma credo che cedergli, senza nemmeno chiedere la mia opinione, un terzo dei proventi oltre a menzionarlo come co-autore nei crediti, sia stato troppo. Come riconoscimento per la session da turnista sarebbero stati sufficienti poche centinaia di dollari. Comunque sono trascorsi trentacinque anni e non nutro alcun rancore nei suoi confronti ma ci tengo a precisare che nessuno di noi ha mai ricevuto un solo centesimo per quel disco, quindi praticamente abbiamo lavorato tutti gratis.
Quindi non è vero che ti diedero solo mille dollari per le vendite di “Hip Hop, Be Bop (Don’t Stop)”.
 I mille dollari li ebbi come compenso per la colonna sonora di “Heatstroke” di cui parlavo prima, ma per quanto riguarda l’album e i singoli non ricevetti assolutamente nulla. La casa discografica mi truffò alla grande su tutta la linea. Sinora quel disco ha venduto oltre cinque milioni di copie ma a me non è stato riconosciuto un solo dollaro. “Hip Hop, Be Bop (Don’t Stop)” inoltre è stata inserita nella colonna sonora del videogame “Grand Theft Auto”, nel film “Shaun Of The Dead” (“L’Alba Dei Morti Dementi” da noi, nda), nel recente documentario “808” dedicato alla Roland TR-808 e in moltissime altre pubblicazioni e compilation in tutto il mondo. L’etichetta che stampò inizialmente il disco ha chiuso battenti da molti anni e i diritti sono passati ad un’altra società, la canadese Unidisc, che ha continuato a sfruttare la mia musica pensando forse che non mi sarebbe interessato più nulla. Li ho portati in tribunale ma ad oggi sono riuscito ad ottenere poco e niente. Adesso però sono molto più scaltro rispetto a quando firmai con la Importe/12 Records, ho imparato le regole del business discografico e reclamo i diritti derivati dallo sfruttamento della mia musica. Molti giovani artisti si eccitano al solo pensiero di veder pubblicati i propri pezzi e non si preoccupano del fatto che le case discografiche possano guadagnare milioni di dollari sfruttando il loro lavoro. La musica è fatta anche di questioni economiche e la gente che vorrebbe entrare a far parte di questo mondo dovrebbe prendere in seria considerazione ciò prima che sia troppo tardi. Oggi inoltre è molto più facile rispetto a quando ho cominciato io, su YouTube o con l’aiuto di Google si possono trovare decine di tutorial con cui apprendere un po’ di nozioni utili per far rivalere i propri diritti. Arrivato a questo punto della mia vita sono comunque felice di continuare a produrre musica in modo autonomo, pubblicandola sulla mia etichetta ed avvalendomi dell’aiuto di qualche avvocato per punire gli imbroglioni.
I mille dollari li ebbi come compenso per la colonna sonora di “Heatstroke” di cui parlavo prima, ma per quanto riguarda l’album e i singoli non ricevetti assolutamente nulla. La casa discografica mi truffò alla grande su tutta la linea. Sinora quel disco ha venduto oltre cinque milioni di copie ma a me non è stato riconosciuto un solo dollaro. “Hip Hop, Be Bop (Don’t Stop)” inoltre è stata inserita nella colonna sonora del videogame “Grand Theft Auto”, nel film “Shaun Of The Dead” (“L’Alba Dei Morti Dementi” da noi, nda), nel recente documentario “808” dedicato alla Roland TR-808 e in moltissime altre pubblicazioni e compilation in tutto il mondo. L’etichetta che stampò inizialmente il disco ha chiuso battenti da molti anni e i diritti sono passati ad un’altra società, la canadese Unidisc, che ha continuato a sfruttare la mia musica pensando forse che non mi sarebbe interessato più nulla. Li ho portati in tribunale ma ad oggi sono riuscito ad ottenere poco e niente. Adesso però sono molto più scaltro rispetto a quando firmai con la Importe/12 Records, ho imparato le regole del business discografico e reclamo i diritti derivati dallo sfruttamento della mia musica. Molti giovani artisti si eccitano al solo pensiero di veder pubblicati i propri pezzi e non si preoccupano del fatto che le case discografiche possano guadagnare milioni di dollari sfruttando il loro lavoro. La musica è fatta anche di questioni economiche e la gente che vorrebbe entrare a far parte di questo mondo dovrebbe prendere in seria considerazione ciò prima che sia troppo tardi. Oggi inoltre è molto più facile rispetto a quando ho cominciato io, su YouTube o con l’aiuto di Google si possono trovare decine di tutorial con cui apprendere un po’ di nozioni utili per far rivalere i propri diritti. Arrivato a questo punto della mia vita sono comunque felice di continuare a produrre musica in modo autonomo, pubblicandola sulla mia etichetta ed avvalendomi dell’aiuto di qualche avvocato per punire gli imbroglioni.
 Il tuo primo album pubblicato nel 1982, “Man Parrish”, conteneva pezzi come “Man Made”, “Six Simple Synthesizers” (coi vocal di Klaus Nomi) e “Techno Trax”, uno dei primissimi ad usare il termine “techno” insieme a “Technodelic” degli Yellow Magic Orchestra (1981), “Technostalgia” dei Techno Twins (1982), “Technopop” di Vee Dee U (1983), “Techno City” dei Cybotron o “Techno-Bush” di Hugh Masekela, entrambi del 1984. Perché optasti per “techno”?
Il tuo primo album pubblicato nel 1982, “Man Parrish”, conteneva pezzi come “Man Made”, “Six Simple Synthesizers” (coi vocal di Klaus Nomi) e “Techno Trax”, uno dei primissimi ad usare il termine “techno” insieme a “Technodelic” degli Yellow Magic Orchestra (1981), “Technostalgia” dei Techno Twins (1982), “Technopop” di Vee Dee U (1983), “Techno City” dei Cybotron o “Techno-Bush” di Hugh Masekela, entrambi del 1984. Perché optasti per “techno”?
Ero indeciso su come intitolare quel pezzo e così scelsi una versione accorciata della parola “technology”. Alla luce di quanto mi dici potrei quindi essere stato uno dei primi ad aver usato la parola “techno” in discografia. Wow!
Di certo sei stato uno dei primi ad aver introdotto l’estetica dell’electronic pop europeo nella club scene americana, combinando la disco sintetica di Giorgio Moroder e la musica delle macchine dei Kraftwerk col nascente hip hop. Come ti venne in mente di mischiare queste influenze?
 Il mio background è rock ma mi è sempre piaciuto il funk e la musica urban che a loro volta mi hanno introdotto ad altri generi. Cerco tuttora di ascoltare cosa producete voi in Europa, la world music orientale o la roba di stampo latino. Ogni stile mi affascina. Le molteplici influenze provenienti da diverse parti del mondo, il desiderio di provare a creare ritmi differenti con le batterie elettroniche e suoni coi sintetizzatori hanno gettato le basi della mia musica e continuano ad alimentarla. Cerco da sempre di ascoltare tutto e poi combinarlo in un perfetto ibrido.
Il mio background è rock ma mi è sempre piaciuto il funk e la musica urban che a loro volta mi hanno introdotto ad altri generi. Cerco tuttora di ascoltare cosa producete voi in Europa, la world music orientale o la roba di stampo latino. Ogni stile mi affascina. Le molteplici influenze provenienti da diverse parti del mondo, il desiderio di provare a creare ritmi differenti con le batterie elettroniche e suoni coi sintetizzatori hanno gettato le basi della mia musica e continuano ad alimentarla. Cerco da sempre di ascoltare tutto e poi combinarlo in un perfetto ibrido.
Sei nato a New York ma le tue origini sono italiane. Hai mai avuto contatti con la scena musicale nostrana?
Gli italiani sono un popolo incredibile quando fanno festa in discoteca e credo abbiano saputo mantenere un proprio stile, inconfondibile. Sono cresciuto a Brooklyn in un quartiere italiano dove tutti ascoltavano musica dance. Durante i sei anni in cui mi sono occupato dei Village People come manager, ho viaggiato moltissimo in tutto il mondo e ricordo sempre con grande affetto le date italiane. L’energia e i locali erano fantastici. Tornai in Italia, a Roma e in Sardegna, quando lavoravo con Crystal Waters ed anche in quelle occasioni l’accoglienza fu la stessa, calorosissima. So che i miei brani sono stati licenziati più volte da etichette italiane ma purtroppo, oltre ai DJ più popolari, non conosco granché.
Come mai nel 1984 la Elektra si rifiutò di pubblicare il tuo secondo album?
 Il mio manager dei tempi era Tony Defries, proprio quel Defries che lavorò con David Bowie. Fu lui a portarmi alla Elektra. Defries però non capiva la dance e continuava a chiedermi di fare rock perché, a suo avviso, era quella la musica che poteva generare denaro. Mi consigliò caldamente di abbandonare i sintetizzatori e formare un gruppo per comporre musica “vera”, perché la cosiddetta “synthesizer music” non sarebbe mai diventata popolare. Pur non condividendo affatto le sue idee pensai che ne sapesse più di me, soprattutto in relazione al mercato discografico. In fin dei conti era stato il manager di un artista come David Bowie e questo, in un certo senso, mi persuase. Così portammo all’Elektra alcuni pezzi rock ma ciò spiazzò del tutto la label, comprensibilmente. Mi avevano fatto firmare un contratto come musicista di musica dance elettronica, un ruolo del tutto nuovo ai tempi, e non come l’ennesimo artista rock. Defries provò ripetutamente a far cambiare idea ai manager ma non ci fu alcuna speranza e mi scaricarono.
Il mio manager dei tempi era Tony Defries, proprio quel Defries che lavorò con David Bowie. Fu lui a portarmi alla Elektra. Defries però non capiva la dance e continuava a chiedermi di fare rock perché, a suo avviso, era quella la musica che poteva generare denaro. Mi consigliò caldamente di abbandonare i sintetizzatori e formare un gruppo per comporre musica “vera”, perché la cosiddetta “synthesizer music” non sarebbe mai diventata popolare. Pur non condividendo affatto le sue idee pensai che ne sapesse più di me, soprattutto in relazione al mercato discografico. In fin dei conti era stato il manager di un artista come David Bowie e questo, in un certo senso, mi persuase. Così portammo all’Elektra alcuni pezzi rock ma ciò spiazzò del tutto la label, comprensibilmente. Mi avevano fatto firmare un contratto come musicista di musica dance elettronica, un ruolo del tutto nuovo ai tempi, e non come l’ennesimo artista rock. Defries provò ripetutamente a far cambiare idea ai manager ma non ci fu alcuna speranza e mi scaricarono.
Il tuo secondo album, intitolato semplicemente “2”, uscì nel 1996, ben quattordici anni dopo il primo. Nel 1998 invece fu la volta di “Dreamtime”, ma chiaramente negli anni Novanta l’electrofunk era ormai acqua passata, seppur proprio in quel periodo stesse nascendo una nuova generazione che lo avrebbe riportato in auge. Come ricordi quella decade?
 I due album furono registrati in un home studio a Brooklyn allestito nella casa dei miei genitori. In quel periodo decine di artisti avrebbero voluto realizzare qualcosa lì. I Village People, Boy George, i Man 2 Man e moltissimi altri si sedevano sul mio letto e cantavano usando il mio microfono e registrando sul mio tape recorder ad otto piste. Incidemmo una quantità pazzesca di musica. Alcuni amici arrivarono a chiamarmi ironicamente “il Prince della musica dance”, perché scrissi una valanga di pezzi come fece il folletto di Minneapolis. Gli anni Novanta furono un decennio davvero interessante, c’erano strascichi di freestyle, electro e funk mentre la house prese piede in maniera sempre più netta. Amai quel periodo perché mi permise di sperimentare suoni in aree stilistiche non più legate solo all’hip hop/electro, come chitarre e tessiture ambient su beat per ballare. Gli anni Novanta restano indimenticabili per la musica dance.
I due album furono registrati in un home studio a Brooklyn allestito nella casa dei miei genitori. In quel periodo decine di artisti avrebbero voluto realizzare qualcosa lì. I Village People, Boy George, i Man 2 Man e moltissimi altri si sedevano sul mio letto e cantavano usando il mio microfono e registrando sul mio tape recorder ad otto piste. Incidemmo una quantità pazzesca di musica. Alcuni amici arrivarono a chiamarmi ironicamente “il Prince della musica dance”, perché scrissi una valanga di pezzi come fece il folletto di Minneapolis. Gli anni Novanta furono un decennio davvero interessante, c’erano strascichi di freestyle, electro e funk mentre la house prese piede in maniera sempre più netta. Amai quel periodo perché mi permise di sperimentare suoni in aree stilistiche non più legate solo all’hip hop/electro, come chitarre e tessiture ambient su beat per ballare. Gli anni Novanta restano indimenticabili per la musica dance.
Negli anni Novanta alcuni DJ erano già molto noti ma in tempi più recenti alcuni hanno raggiunto lo status di pop/rock star. Credi sia positivo?
Conosco molta gente che critica il mondo EDM ma senza questo fenomeno credo che la dance non si sarebbe mai diffusa in modo capillare in tutto il mondo. Ovviamente, come in tutti gli stili, c’è del buono e del meno buono. EDM sta per Electronic Dance Music ma gran parte della gente ignora ciò. Praticamente tutto quello che ho fatto dal 1972 ad oggi col mio sintetizzatore potrebbe essere etichettato come EDM! Ma l’EDM ha pure un lato cheesy? Certo. Chiunque oggi, nella propria stanzetta, può mettere un ritmo in loop per cinque minuti e definire “disco” il risultato. Non sono contrario a questo, sia chiaro, ovviamente chi se ne intende preferirà sempre la musica fatta con criterio ma credo che nel mondo ci sia spazio per tutto ed ognuno abbia il diritto di esprimersi come meglio crede. Quando ero un adolescente, negli anni Settanta, non esisteva ancora la DJ culture. Andavi in un club e nel 90% dei casi non avresti mai saputo chi era il DJ che metteva musica. Il fenomeno dei DJ è nato soprattutto negli anni Novanta con personaggi come l’amico Frankie Knuckles, che purtroppo ci ha già lasciati. Il pubblico cominciò ad andare nei locali per ascoltare lui e non più la musica o semplicemente divertirsi. Penso sia fantastico se oggi alcuni DJ riescano a guadagnare 10.000 dollari a serata di fronte a migliaia di persone disposte a pagare per vederlo. Non credo dunque che i “DJ star” stiano danneggiando la DJ culture, anzi, potrebbero ispirare i cosiddetti “bedroom DJ” ad impegnarsi di più. Negli anni Ottanta la dance music era considerata un fenomeno estremamente underground e solo Billboard aveva una classifica dance, che comunque era ritenuta la meno rilevante dell’intero giornale. Nessun artista, produttore, remixer o DJ dance avrebbe mai potuto vincere un Grammy Award quindi considero positivo tutto ciò che ha portato questa musica nel mainstream, perché alla fine sarà il pubblico ad eleggere ciò che è bello e ciò che non lo è. Se è terribile non durerà molto, se è valido si trasformerà in un classico, come accaduto ai miei brani (ride).
Il tuo nuovo album, la cui uscita è prevista nelle prossime settimane, si intitola “Star” e contiene numerose cover di brani famosi, come “Situation” di Yazoo, “Blue Monday” dei New Order, “Menergy” e “Megatron Man” di Patrick Cowley, “You Used To Hold Me” di Ralphi Rosario, “Strangelove” dei Depeche Mode, “New York City Boy” dei Pet Shop Boys, “Total Eclipse” di Klaus Nomi e “Cars” di Gary Numan, giusto per citarne alcuni. Come mai hai optato per un concept di questo tipo anziché scrivere pezzi inediti?
 Vorrei precisare che sono assolutamente in grado di scrivere musica nuova, ho pubblicato 107 brani su iTunes e su altre piattaforme digitali. Inoltre ho composto 100 brani per film e 120 per orchestre di musica classica. Dopo aver letto questa intervista la gente che non mi conosce potrebbe visitare la mia pagina Soundcloud dove è possibile ascoltare alcuni miei brani non legati alla musica dance. Tornando alla tua domanda, ci sono delle canzoni che preferisco di più rispetto ad altre, così ho deciso di farle mie reinterpretandole. Ecco la ragione dietro “Star”, nulla di più semplice.
Vorrei precisare che sono assolutamente in grado di scrivere musica nuova, ho pubblicato 107 brani su iTunes e su altre piattaforme digitali. Inoltre ho composto 100 brani per film e 120 per orchestre di musica classica. Dopo aver letto questa intervista la gente che non mi conosce potrebbe visitare la mia pagina Soundcloud dove è possibile ascoltare alcuni miei brani non legati alla musica dance. Tornando alla tua domanda, ci sono delle canzoni che preferisco di più rispetto ad altre, così ho deciso di farle mie reinterpretandole. Ecco la ragione dietro “Star”, nulla di più semplice.
Il primo singolo è “Do You Wanna Funk”, cover dell’omonimo di Patrick Cowley e Sylvester, che hai realizzato insieme al duo italiano degli Hard Ton. Come è nata questa collaborazione?
Quando Cowley morì, nel 1982, il proprietario della Megatone Records mi contattò chiedendomi di produrre pezzi per Sylvester. Quest’ultimo però odiava la mia musica ma non perché fosse fatta male. Lui voleva pezzi funk/R&B suonati dalle band in carne ed ossa e non coi sintetizzatori, strumenti che peraltro erano particolarmente impopolari in quel periodo perché considerati veicoli di musica non “reale”. Paul Parker lavorava per la stessa label e il proprietario ci mise in contatto permettendoci di diventare buoni amici e lavorare insieme. Parker aveva già collaborato in un paio di occasioni con gli Hard Ton e così, visto che piacevano pure a me, ho proposto un lavoro in team. Paul era entusiasta e dopo le email di presentazioni abbiamo fatto un meeting virtuale su Skype. Ho chiesto a Max se fosse disposto a reinterpretare “Do You Wanna Funk” vista la sua estensione vocale e dopo aver avuto conferma, nell’arco di pochi giorni gli ho mandato la traccia. Ha registrato il vocal nel suo studio e me lo ha rimandato. Ho lavorato un po’ sull’editing, c’è stato un ping pong di messaggi per curare altri accorgimenti e alla fine il risultato è quello che potete sentire adesso. Sono davvero contento di aver collaborato con gli Hard Ton e spero che lo siano altrettanto loro. Non nascondo che mi piacerebbe incidere altri pezzi insieme, adoro i loro video e vorrei poterne realizzare uno pure per il nostro brano. Credo davvero che Max sia il nuovo Sylvester ma con una marcia in più. Sylvester era troppo conservatore e si preoccupava di ciò che la gente avrebbe potuto pensare, Max degli Hard Ton invece è fantastico ed audace, lo adoro.
“Star” è pieno zeppo di collaborazioni con artisti di varia estrazione, dal citato Paul Parker al compianto Steve Strange, da Joey Arias a Steve Bronski sino ad Ernesto Tomasini. Perché ti sei avvalso di così tanti featuring?
 L’album si chiama “Star” proprio perché tutti gli amici che ho coinvolto sono delle star, ognuno nel proprio campo. Si tratta di artisti che ho conosciuto nel corso degli anni, chi online e chi di persona, con cui ho avuto il piacere di condividere esperienze di vario tipo. Ognuno di loro è estremamente unico in ciò che fa. Non avere più un pubblico mainstream mi ha dato facoltà di lavorare liberamente con svariati talenti. Gran parte dei pezzi racchiusi in “Star” potrebbero suonare “vecchi” ma è stato un effetto voluto, ho intenzionalmente lavorato in tal senso per ricreare la classica “pasta” del retro sound. Solo due o tre tracce sono state estratte dal mio archivio, il resto è di recente produzione. Nel momento in cui dovevo decidere il titolo, “Star” mi è sembrata la scelta più logica vista la presenza massiccia di tanti ospiti, ben tredici.
L’album si chiama “Star” proprio perché tutti gli amici che ho coinvolto sono delle star, ognuno nel proprio campo. Si tratta di artisti che ho conosciuto nel corso degli anni, chi online e chi di persona, con cui ho avuto il piacere di condividere esperienze di vario tipo. Ognuno di loro è estremamente unico in ciò che fa. Non avere più un pubblico mainstream mi ha dato facoltà di lavorare liberamente con svariati talenti. Gran parte dei pezzi racchiusi in “Star” potrebbero suonare “vecchi” ma è stato un effetto voluto, ho intenzionalmente lavorato in tal senso per ricreare la classica “pasta” del retro sound. Solo due o tre tracce sono state estratte dal mio archivio, il resto è di recente produzione. Nel momento in cui dovevo decidere il titolo, “Star” mi è sembrata la scelta più logica vista la presenza massiccia di tanti ospiti, ben tredici.
Oltre agli Hard Ton in “Star” c’è un’altra presenza italiana, quella di Ernesto Tomasini: si tratta forse di un omaggio alla passata collaborazione con Klaus Nomi?
 Tomasini ha già lavorato con artisti del calibro di Peter Christopherson (Coil, Psychic TV, Throbbing Gristle) e Sam Shackleton (il loro album “Devotional Songs” è stato eletto tra i migliori dischi dell’anno da Wire, The Quietus e molte altre riviste). Presto uscirà un documentario sulla sua vita in cui peraltro figurerò anche io. Sono nel business discografico da molti anni e ammetto, senza timore di smentita, che Tomasini abbia una voce a dir poco sorprendente. La sua artisticità e creatività sono rare, soprattutto oggi. L’estensione vocale di Klaus Nomi, come dicevi tu prima, è effettivamente molto simile a quella di Tomasini ma nonostante ciò sono due artisti completamente differenti l’uno dall’altro, sebbene in tanti definiscano quest’ultimo una specie di reincarnazione moderna di Nomi. La prima volta che vidi Klaus rimasi a bocca aperta, facemmo una serata insieme a New York e lui cantava in falsetto come se stesse interpretando l’opera lirica. Tutti pensarono che stesse solo mimando cantando in playback eppure no, lui cantava dal vivo, senza ricorrere a nessun trucco! Lasciò tutti di sasso, era come un alieno, con una voce che contrastava fortemente col suo look. Nel camerino gli feci i complimenti e mi confidò di amare profondamente la synthesizer music e che quindi avrebbe voluto incidere qualcosa in quella direzione. Diventammo amici ed iniziammo a lavorare su alcune tracce di stampo sperimentale. Un mese più tardi firmò il contratto con la RCA Victor e cominciai a lavorare ai suoi primi due album, “Klaus Nomi” del 1981 e “Simple Man” del 1982, programmando i sintetizzatori in studio. Ricordo però il suo nervosismo quando gli chiedevano di cantare su basi rock (come “Lightning Strikes”, “You Don’t Own Me”, “Total Eclipse” o “After The Fall” nda), cosa che non voleva affatto fare. Gli dissi che l’importante, in quel momento, era pubblicare musica in modo da far crescere la propria fama e giungere al giorno in cui avrebbe potuto decidere autonomamente che fare ignorando quanto imposto dai manager. Klaus non mandava giù che la sua carriera potesse dipendere da qualcuno che magari ne sapesse poco e niente di musica. È ancora più triste pensare che sia morto sapendo quanta gente nel mondo avrebbe potuto amare ulteriormente la sua arte. Tomasini invece, al contrario di Nomi, è completamente padrone della sua carriera e riesce brillantemente a combinare musica e teatro. Tenete a mente il suo nome e cercate di andare ad un suo concerto, vi garantisco che è incredibile.
Tomasini ha già lavorato con artisti del calibro di Peter Christopherson (Coil, Psychic TV, Throbbing Gristle) e Sam Shackleton (il loro album “Devotional Songs” è stato eletto tra i migliori dischi dell’anno da Wire, The Quietus e molte altre riviste). Presto uscirà un documentario sulla sua vita in cui peraltro figurerò anche io. Sono nel business discografico da molti anni e ammetto, senza timore di smentita, che Tomasini abbia una voce a dir poco sorprendente. La sua artisticità e creatività sono rare, soprattutto oggi. L’estensione vocale di Klaus Nomi, come dicevi tu prima, è effettivamente molto simile a quella di Tomasini ma nonostante ciò sono due artisti completamente differenti l’uno dall’altro, sebbene in tanti definiscano quest’ultimo una specie di reincarnazione moderna di Nomi. La prima volta che vidi Klaus rimasi a bocca aperta, facemmo una serata insieme a New York e lui cantava in falsetto come se stesse interpretando l’opera lirica. Tutti pensarono che stesse solo mimando cantando in playback eppure no, lui cantava dal vivo, senza ricorrere a nessun trucco! Lasciò tutti di sasso, era come un alieno, con una voce che contrastava fortemente col suo look. Nel camerino gli feci i complimenti e mi confidò di amare profondamente la synthesizer music e che quindi avrebbe voluto incidere qualcosa in quella direzione. Diventammo amici ed iniziammo a lavorare su alcune tracce di stampo sperimentale. Un mese più tardi firmò il contratto con la RCA Victor e cominciai a lavorare ai suoi primi due album, “Klaus Nomi” del 1981 e “Simple Man” del 1982, programmando i sintetizzatori in studio. Ricordo però il suo nervosismo quando gli chiedevano di cantare su basi rock (come “Lightning Strikes”, “You Don’t Own Me”, “Total Eclipse” o “After The Fall” nda), cosa che non voleva affatto fare. Gli dissi che l’importante, in quel momento, era pubblicare musica in modo da far crescere la propria fama e giungere al giorno in cui avrebbe potuto decidere autonomamente che fare ignorando quanto imposto dai manager. Klaus non mandava giù che la sua carriera potesse dipendere da qualcuno che magari ne sapesse poco e niente di musica. È ancora più triste pensare che sia morto sapendo quanta gente nel mondo avrebbe potuto amare ulteriormente la sua arte. Tomasini invece, al contrario di Nomi, è completamente padrone della sua carriera e riesce brillantemente a combinare musica e teatro. Tenete a mente il suo nome e cercate di andare ad un suo concerto, vi garantisco che è incredibile.
Stai già pensando ad eventuali remix?
Mi è sempre piaciuto realizzare remix ma prima vorrei vedere come funziona questo album. Sto attendendo l’intervento di una persona a cui ho chiesto di occuparsi della promozione. Qualora non accettasse, andrò avanti da solo.
Nell’intervista di Steven Jones pubblicata a febbraio 2013 ho letto alcune tue opinioni in merito al nuovo modo di fare business nella musica, come iTunes o CD Baby, che sono esattamente opposte rispetto a quelle di tanti altri tuoi colleghi che rimpiangono fortemente i bei tempi andati, quando si potevano guadagnare molti soldi attraverso la sola vendita dei supporti. Deduco quindi che consideri positivamente i cambiamenti imposti dalla digitalizzazione.
 Adesso è il momento migliore per un artista che desidera pubblicare la propria musica. In passato eri costretto a ricorrere al supporto di etichette e la gente non sa che la maggior parte degli artisti ha ricevuto solo il 10% delle royalties derivate dalla vendita dei propri dischi. Le compagnie discografiche sono abili nel raggirare e, molto più spesso di quel che si creda, sono disoneste anche nel riportare le cifre di vendita agli artisti, una delle ragioni per cui il business è collassato. Credo che il karma abbia già punito chi si è macchiato di tali colpe, ma sfortunatamente non mancano dirigenti sleali che si occupano dello streaming. Da quando il web è diventato un media a tutti gli effetti si è fatto davvero poco per proteggere gli artisti e la loro musica da servizi come Pandora, YouTube o altri simili. Il pubblico non sa che ogni volta che si ascolta un brano su queste piattaforme, l’artista percepisce una somma infinitamente microscopica, lo 0,0025. In relazione a ciò, recentemente è emerso il caso di un artista noto che per cinque milioni di play ha ricevuto appena cento dollari. Questo è il motivo per cui molta musica di oggi non è curata come quella di un tempo, non c’è motivazione se non quella dell’amore per la musica stessa. I musicisti, prima di essere tali, sono esseri umani ed hanno bisogno di pagare l’affitto e fare la spesa. Molti di loro ormai sono stati costretti a trovarsi un lavoro quotidiano per sopravvivere. Poi, quando tornano a casa la sera, sono troppo stanchi per registrare musica o occuparsi della propria carriera. È terribile, lo so, ma c’è anche un rovescio della medaglia. Come artista indipendente ad esempio posso pubblicare tutta la musica che voglio e quando voglio, e gli eventuali profitti sono i miei. Posso decidere autonomamente se cedere i miei pezzi a servizi di streaming, insomma sono responsabile di me stesso e della mia carriera, di cosa voglio fare e quale direzione prendere. Essere sganciati da un’etichetta discografica significa essere autenticamente e creativamente liberi e questo credo sia bellissimo. Ovviamente è necessario apprendere il funzionamento del business altrimenti si potrebbe perdere tutto, col rischio di cadere in depressione e porre fine alla propria carriera. L’unico modo per guadagnare denaro oggi è fare serate e tour, cosa fattibile per un cantante ma meno facile per uno come me, abituato a vivere in studio. Tuttavia sarei disposto a fare un tour, a patto che le persone coinvolte siano quelle giuste.
Adesso è il momento migliore per un artista che desidera pubblicare la propria musica. In passato eri costretto a ricorrere al supporto di etichette e la gente non sa che la maggior parte degli artisti ha ricevuto solo il 10% delle royalties derivate dalla vendita dei propri dischi. Le compagnie discografiche sono abili nel raggirare e, molto più spesso di quel che si creda, sono disoneste anche nel riportare le cifre di vendita agli artisti, una delle ragioni per cui il business è collassato. Credo che il karma abbia già punito chi si è macchiato di tali colpe, ma sfortunatamente non mancano dirigenti sleali che si occupano dello streaming. Da quando il web è diventato un media a tutti gli effetti si è fatto davvero poco per proteggere gli artisti e la loro musica da servizi come Pandora, YouTube o altri simili. Il pubblico non sa che ogni volta che si ascolta un brano su queste piattaforme, l’artista percepisce una somma infinitamente microscopica, lo 0,0025. In relazione a ciò, recentemente è emerso il caso di un artista noto che per cinque milioni di play ha ricevuto appena cento dollari. Questo è il motivo per cui molta musica di oggi non è curata come quella di un tempo, non c’è motivazione se non quella dell’amore per la musica stessa. I musicisti, prima di essere tali, sono esseri umani ed hanno bisogno di pagare l’affitto e fare la spesa. Molti di loro ormai sono stati costretti a trovarsi un lavoro quotidiano per sopravvivere. Poi, quando tornano a casa la sera, sono troppo stanchi per registrare musica o occuparsi della propria carriera. È terribile, lo so, ma c’è anche un rovescio della medaglia. Come artista indipendente ad esempio posso pubblicare tutta la musica che voglio e quando voglio, e gli eventuali profitti sono i miei. Posso decidere autonomamente se cedere i miei pezzi a servizi di streaming, insomma sono responsabile di me stesso e della mia carriera, di cosa voglio fare e quale direzione prendere. Essere sganciati da un’etichetta discografica significa essere autenticamente e creativamente liberi e questo credo sia bellissimo. Ovviamente è necessario apprendere il funzionamento del business altrimenti si potrebbe perdere tutto, col rischio di cadere in depressione e porre fine alla propria carriera. L’unico modo per guadagnare denaro oggi è fare serate e tour, cosa fattibile per un cantante ma meno facile per uno come me, abituato a vivere in studio. Tuttavia sarei disposto a fare un tour, a patto che le persone coinvolte siano quelle giuste.
Stai considerando l’ipotesi di pubblicare la tua musica anche su vinile? Per molti collezionisti il disco resta il formato migliore per ascoltare musica.
Comprendo il buzz che gravita ora intorno al vinile. “Star” contiene più di venti pezzi per oltre due ore di musica. Dovrei sceglierne cinque ed adattarli alle durate del vinile, visti i limiti tecnici di questo supporto. Stamparlo tutto su un doppio album sarebbe piuttosto costoso, anche perché occorrerebbe un nuovo master, la copertina ed altri dettagli. Inoltre distribuire in tutto il mondo un doppio vinile costerebbe parecchio, perché il peso influisce sensibilmente sul prezzo delle spedizioni e ciò limiterebbe ulteriormente i profitti, non è pensabile di venderlo ad un costo troppo elevato. Spedire dagli Stati Uniti in Italia o in Europa è un problema e la spesa alla fine non invoglierebbe l’acquisto. Certo, si potrebbe stampare il disco direttamente in Europa ma nessuno verificherebbe che il lavoro sia fatto a regola d’arte e che la stamperia non giochi qualche sgradito scherzo, magari stampando qualche centinaio di copie in più da vendere a mia insaputa. Accade molto frequentemente che le stamperie facciano ciò, immettendo sul mercato bootleg ed incisioni non autorizzate. In circolazione ci sono migliaia di dischi realizzati in questo modo da pressing plant disoneste e fatti circolare da distributori senza scrupoli. Quando uscì il mio primo album, l’FBI e la RIAA (Associazione Americana dell’Industria Discografica, nda) investigarono e costrinsero alla chiusura una stamperia localizzata ai Caraibi che aveva prodotto oltre un milione di copie illegali del disco. Mi rendo conto che il suono digitale sia diverso da quello analogico perciò mi impegnerò a cercare un modo per accontentare i fan del vinile, tentando di percorrere una strada economicamente compatibile con le mie possibilità. Purtroppo non posso stampare solo cento copie per i collezionisti, le stamperie impongono una tiratura minima e se alla fine non riesci a vendere almeno mille copie del prodotto non si potranno neanche pareggiare i costi.
Come immagini la musica elettronica delle prossime decadi?
Il mondo sarà invaso da iPad, iPhone e computer sempre più potenti. Nella sound library dell’app BeatMaker ci sono anche cose mie, e sono contento di essere stato coinvolto in questo progetto, diversi anni fa. Ho concesso ai programmatori alcuni sample e parte del materiale originale delle mie incisioni. In quel momento ho capito che non avevo più bisogno di un costoso computer da almeno quattromila dollari per registrare musica. Inoltre ero libero di comporre in qualsiasi luogo, senza più essere costretto a restare in una stanza piena di apparecchiature. Prestate attenzione alla facoltà di registrazione che oggi ci viene offerta dai dispositivi mobili: GarageBand è sul vostro iPhone o iPad e non è altro che il “fratellino” di Logic che solitamente si adopera negli studi canonici. Si possono programmare beat, sample, scrivere arrangiamenti e canzoni intere disponendo di sintetizzatori multipli che eseguono parti diverse. Insomma, è sufficiente lanciare un’applicazione dal proprio iPhone o iPad per scrivere musica, magari mentre si passeggia per strada con le cuffie nelle orecchie. Il risultato audio non è di scarsa qualità, anzi, è paragonabile al suono che di solito si sente sui CD. Per quanto riguarda gli stili invece, credo che tutti i generi di musica, nuovi e vecchi, diventeranno popolari. Quando ero un ragazzino c’era disco, rock, jazz e musica classica, oggi invece c’è l’imbarazzo della scelta, solo prendendo in esame la dance ci si può imbattere in house, garage, 2 step, drum n bass, ambient, electro e chi più ne ha più ne metta. La cosa più importante, inoltre, è che la gente ora ascolta in modo diverso tutto ciò che è nuovo, senza troppi pregiudizi. Il futuro quindi mi sembra fantastico e certamente ne farò parte.

