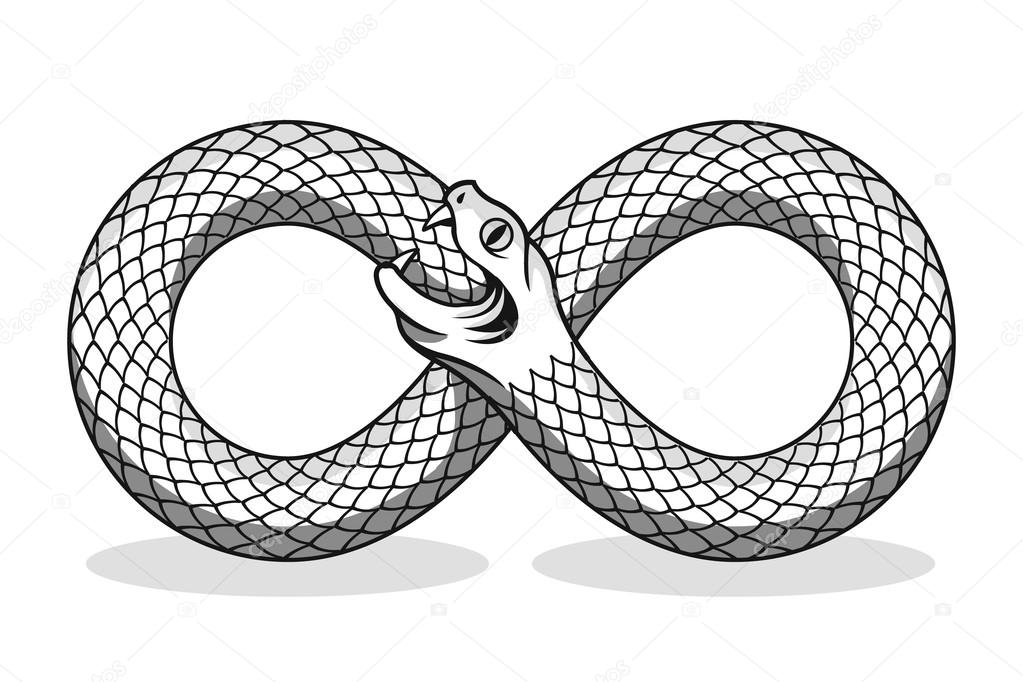Ad oggi, 12 maggio 2020, non è ancora minimamente chiaro che ne sarà di concerti, club, discoteche, festival nel nostro futuro. Oddio, ormai una cosa è data per acquisita: per quest’estate possiamo dare addio ai festival. L’”ultimo mohicano” è stato il Sónar, che fino all’ultimo aveva tenuto almeno ufficialmente il punto sulle date originarie (metà giugno, praticamente dopodomani) ma che qualche giorno fa ha gettato la spugna e dato appuntamento a tutti per il 2021. Ma anche chi aveva spostato tutto da inizio a fine estate, pensiamo al Primavera, ha dovuto alzare bandiera bianca pure per il termine-bis che ci si era dati, con ragionevole ottimismo, ad inizio pandemia: niente giugno o luglio, ok, e quello si sapeva, ma ora nemmeno fine agosto o inizio settembre come successivamente – ed è un discorso che riguarda pure l’Italia, vedi Nameless (annunciato oggi: si va al 2021) e Kappa FuturFestival (annunciato la settimana scorsa: idem). Naturalmente anche i festival che erano in date inizialmente più “protette/fattibili”, pensiamo ad esempio al nostro amato FAT FAT FAT agostano, hanno smesso di vivere nell’incertezza e hanno deciso di dare direttamente appuntamento all’anno prossimo.
E’ un piccolo terremoto. Anzi, piccolo un cazzo: grande. Vanno in fumo non solo alcuni dei nostri divertimenti estivi (che poi, non era solo divertimento: era un modo per fare turismo, vedere posti belli, valorizzare territori, incontrare persone interessanti, entrare in contatto con nuove energie e prospettive), ma in fumo ci vanno anche – e soprattutto – milioni di fatturato, migliaia di posti di lavoro. Un paio di settimane fa avevamo affrontato la questione inquadrandola dal punto di vista specifico del clubbing (clubbing che, forse, riprenderà dopo l’estate: e questa sarebbe già la previsione più ottimistica). Oggi allarghiamo l’obiettivo ai festival e alla musica del vivo, ai concerti. Anche nella consapevolezza che, pur nelle specificità di ciascuno, siamo tutti sulla stessa barca.
Oh, questa cosa delle specificità non la diciamo gratis: ci sono, ci sono eccome, ci sono così tanto che per quanto riguarda il clubbing più propriamente detto ci schieriamo chiari su una linea: il clubbing per definizione, così com’è nato e per quello che rappresenta, non può esistere con limitazioni, controlli maniacali, distanziamenti. Inutile cercare delle scorciatoie. O meglio, non è “inutile”: quando si tratta di salvare la propria sussistenza e magari posti di lavoro nulla è “inutile”, e uno può anche rassegnarsi a barcamenarsi sul crinale del “danno minore” (è una cosa che dovranno imparare in tanti, chi già da ora chi da dopo l’estate). Però sta di fatto che se c’è da prendere una posizione, per quanto ci riguarda la posizione del clubbing rispetto a limitazioni “di sicurezza” varie ed assortite è chiara: no, grazie, preferiamo aspettare ed inventarci qualcosa per sopravvivere, piuttosto che riaprire ad ogni costo in un contesto forzatamente asettico e distanziato.
Ma che si sia tutti nella stessa barca è dimostrato da un punto che via via emerge sempre più come cruciale e collettivo, per chi fa cultura di un certo tipo: quello dei cachet, quello delle spese di produzione. Quando hai a che fare con eventi nella musica, che sia quella dei live o che sia quella dei dj, stai infatti camminando su un crinale molto strano: perché tolto il mercato sui generis (ed artisticamente stantio) delle cover band e delle discoteche “commerciali”, che sono un discorso a parte, ovunque venga fatto un discorso un minimo culturale ed evolutivo attorno alla musica si ha a che fare con una rivoluzione che ha aperto in due le dinamiche del mercato, come una mela: ovvero lo spostamento dei profitti, che in maniera brusca si sono trasferiti dalla vendita della musica in sé (e dei supporti fisici che la veicolano) come fonte di guadagno primaria alla sfera invece dei live, dell’evento, della serata, del festival, del concerto, del dj set, eccetera eccetera.
Anche prima del lockdown e della pandemia stavamo vivendo una rivoluzione, che aveva aperto in due il sistema-musica e le sue dinamiche di mercato
Un cambiamento drastico e radicale, avvenuto in poco tempo, che ha sconquassato un equilibrio precedente lungo decenni e su cui molti si erano felicemente adagiati. Come spesso accade, la club culture in questo è stata un apripista: è infatti forse il primo contesto dell’industria musicale dove iniziavi a guadagnare di più suonando in giro (coi dj set) che vendendo dischi e avendo una carriera discografica “normale”. Quando diciamo che la club culture è il campo dell’innovazione non lo diciamo insomma solo perché “…suona bene”, ma perché ne siamo davvero convinti fatti alla mano. Sia come sia: l’attenzione proprio precipuamente industriale del sistema-musica si è spostata dal disco all’esibizione dal vivo, ed è quindi sull’esibizione dal vivo che ha concentrato le proprie energie più efficaci, ciniche, utilitaristiche, massimizzatrici di profitto (…poi ok, le major hanno trovato il modo di fare soldi dallo streaming e pure tanti, ma quello è un altro discorso: dato che è chiaro per tutti che dallo streaming ci guadagnano solo loro e nessun altro – non i musicisti, non le label piccole ed indipendenti, non i tecnici del suono, non i grafici ed i fotografi… al massimo i social media manager, toh).
Risultato concreto? Quando il capitale “serio” ci si mette di buzzo buono, le dinamiche del mercato le cambia eccome. Dategli qualche anno, e ce la fa. Se poi addirittura viene a cadere l’energia ideale dell’essere indipendenti ed alternativi, perché in maniera più che legittima e ragionevole la scena indipendente ed alternativa vuole smettere di essere gregaria e relegata all’hobbysmo, il risultato è davvero netto ed univoco: tutti decidono di adeguarsi al “pensiero unico” per cui dalla presenza dell’artista in carne ed ossa ad un evento, che sia un concerto o un dj set, bisogna estrarre il massimo valore possibile.
Per farlo e per riuscirci, che fai? Non basta “volerlo”, infatti. Devi anche investire. Devi creare degli spettacoli sempre più grandi e più belli, devi lavorare sempre di più e meglio sulla comunicazione attorno all’artista, devi insomma rendere appetibile e “preziosa” la tua merce, se vuoi che il mercato la vada a cercare il più possibile. Il marketing attorno alla musica c’è sempre stato (e sempre ci sarà), non è che sia una novità di questi tempi, la differenza è che ora è concentrato tutto sul massimizzare o la fuffa (leggi: l’artista che diventa testimonial pubblicitario utile per i brand, che sono i migliori pagatori) o la musica dal vivo. Visto che è venuto (momentaneamente?, parzialmente?) a cadere lo spirito “alternativo” ed “indipendente” anche fra chi dall’”alternativo” ed “indipendente” è nato, ci sono sempre meno freni a questa corsa.
Attenzione. Non stiamo dicendo che tutti gli artisti, i loro management e loro agenzie di booking sono degli empi senza cuore, che pensano solo a spremere soldi dagli appassionati costi quel che costi. Questo processo da molti è cavalcato in perfetta buona fede: ovvero, “…cerco di offrirti il miglior spettacolo possibile”. Cerco di darti qualcosa in più perché metto quella trovata scenografica in più, perché giro con quel paio di backliner in più che mi fanno sentire più a mio agio quando poi salgo sul palco, perché con un social media manager bravo anche tu poi vendi dei biglietti in più quando mi chiami a suonare o, se sei spettatore, sei in mezzo ad uno spettacolo più coinvolgente. Eccetera eccetera eccetera. Come puoi prendertela con un artista se cerca di offrirti lo spettacolo migliore possibile?
Come puoi prendertela con un artista se cerca di offrirti lo spettacolo migliore possibile? In realtà, puoi. E forse devi
Il problema è che tutta questa sfera, con la compiacenza e l’incoraggiamento di chi muove i grandi capitali mainstream, ha iniziato a crescere tanto, troppo, ha iniziato a crescere in maniera scollegata rispetto a quello che sarebbe stato di suo il tasso naturale di crescita, autogiustificandosi, trovando sempre un perché a continue nuove richieste e nuove voci di spesa. Dei cachet dei dj (troppo) alti abbiamo parlato, straparlato e riparlato, e ne riparleremo pure, chiaro; ma questo è un fenomeno che è solo rifrazione di quello che già stava accadendo anni prima nella sfera dei live, dei concerti.
Chi sette, otto anni fa (ma anche quattro o cinque…) chiedeva 5.000 euro per uno show ora ne chiede 15.000 (o anche 50.000, se il vento hipsterico è a favore); chi ne chiedeva 50.000 ora chiede almeno 200.000; chi ne chiedeva 250.000 ora per meno di un paio di milionate non si degna nemmeno di risponderti al telefono o ad una mail. Chi lavora nel mercato del live lo sa. E non c’è tasso di inflazione al mondo che giustifichi aumenti del genere.
L’accrescimento del volume finanziario delle transazioni ha una dinamica in cui si arricchiscono di più gli artisti, si arricchiscono di più i loro manager e le loro agenzie, si dà lavoro a più personale tecnico (ma raramente a più soldi: un facchino prende X sia che porti i bauli di una band medio-piccola che quelli dei Depeche Mode o di Lady Gaga, e pure i tecnici non è che guadagnino così tanto di più), ad impoverirsi invece sono i promoter – che vedono assottigliati i margini ed aumentato a dismisura il rischio d’impresa – e il pubblico, ma quest’ultimo come già detto è (per ora, e forse solo apparentemente) contento di spendere soldi in più, per vedere musica dal vivo.
Bello. Ma non sostenibile sul lungo termine. Perché se i promoter crollano sotto il peso delle perdite e dei guadagni troppo sottili e un bel giorno il pubblico decide di cambiare gusti (come è suo diritto farlo: perché ha meno soldi, o perché vuole spenderli diversamente), beh, il crollo può essere disastroso. Ed è un crollo che andrebbe ad investire prima di tutto chi è già debole: gli artisti di fama minore, quelli più di nicchia, e le persone che a vario titolo prestano il proprio lavoro e la propria professionalità nella realizzazione dei concerti dal vivo – ovvero i famosi facchini e tecnici che già ora non stanno partecipando più di tanto al banchetto, apparecchiato invece ai piani alti.
Ora: può legittimamente non fregarvene un cazzo. Ascoltate solo la musica alla radio o distrattamente sul web, andate a un concerto ogni morte di papa, a voi vi interessa solo divertirvi e ciao. Va bene. Ma tutti gli altri – e se state leggendo queste righe ci auguriamo facciate parte di tutti gli altri – speriamo che tutto questo suoni come un pericoloso campanello d’allarme. Un fenomeno potenzialmente cancerogeno in grado di togliere la salute all’intero sistema.
E’ da questi presupposti che è nato un interessante appello, “Cambiamo musica?”, che vi proponiamo qui sotto. Leggetelo.
Letto? Bene. Tirate voi le vostre conclusioni, decidete pure voi quanto il tutto sia appropriato o meno e quanto valga la pena schierarsi o meno, però è indubbio che vengono sollevati dei problemi reali: l’aumento esponenziale dei cachet e delle spese di produzione, il prezzo d’ingresso di conseguenza sempre più alto, le imposizioni da parte dei grandi gruppi dell’intrattenimento (vedi canali di prevendita), il fatto che tutto questo ingigantirsi dei numeri e dei profitti non si sia tradotto in maggiori tutele per tecnici e lavoratori dello spettacolo.
Preso nota di questo, torniamo poi alla situazione contingente (e drammatica) che si è creata all’improvviso, il lockdown da Covid-19 e una ripresa che è ancora dai confini sia temporali che quantitativi molto, molto incerta. C’è stata una intervista molto interessante di Rockit dove, intervistando Claudio Trotta di Barley Arts e Pietro Fuccio di DNA Concerti, è emerso un messaggio univoco: ok, bene tutto, ma qui bisogna anche pensare piano piano a come ripartire. E se, come dicevamo, per quanto riguarda il clubbing questo è un discorso più sdrucciolevole (andrebbe ripensata l’esperienza club e traslata verso qualcosa di completamente diverso, probabilmente immersivo, polisensoriale, da performance d’arte) nel caso invece dei live ci sono già le possibilità di pensare a dei modelli per riprendere ad operare.
Modelli che giocoforza abbandonano al momento l’idea delle grandi, grandissime adunate, ma che (ri)pensano invece a scale più piccole, a contesti più intimi, a situazioni più gestibili. Una sorta di “decrescita obbligata”, resa necessaria dal percorso – presumibilmente graduale e non corto – di uscita dalla pandemia. Se insomma prima l’essere nemici del gigantismo e della crescita continua ed incontrollata era solo un richiamo “etico” anche opinabile (o, in prospettiva, nato dalla paura di evitare un collasso improvviso del sistema, come la rana che si gonfia troppo e poi esplode: ma lì è facile sembrare degli sfigati profeti di sventura, e spesso lo si è davvero), ora a tutto questo si unisce anche una necessità pratica, inevitabile, obbligata. Quale miglior occasione?
Già. Quale miglior occasione, per tornare ad occuparsi di quanto (e quando) sia giusto che gli eventi musicali live siano sempre più grandi e costosi. O quanto sia giusto che i prezzi dei biglietti siano in ascesa molto più del potere d’acquisto medio delle persone e nessuno abbia nulla da ridire. O quanto sia giusto che i profitti e i rischi siano distribuiti in maniera non equa. O quanto abbia senso che i dj/musicisti in ascesa guadagnino il triplo solo perché in ascesa nel mercato dei social e dell’informazione, e non perché abbiano triplicato il loro pubblico.
Domande importanti. Molto importanti. Che non devono sfociare nel luddismo de “Basta grandi eventi”, “Basta megastar”, “Basta festival che puntano tutto o troppo sulla spettacolarità, sui grandi nomi, sui grandi numeri”: la musica non può essere ostaggio solo delle nicchie, delle sette, dell’underground, dell’alternativa, la musica dev’essere libera. E deve anche essere spettacolare, se le va, con fuochi d’artificio, ledwall ed effetti speciali. Ma una riflessione imprenditoriale collettiva, per evitare che il giocattolo ci esploda in mano, è necessaria; lo era già da qualche anno, il dramma della pandemia – perché per molti, ricordiamolo, è un dramma davvero – ci ha “aiutato” a ricordarcene ancora meglio, ancora di più, ancora prima.