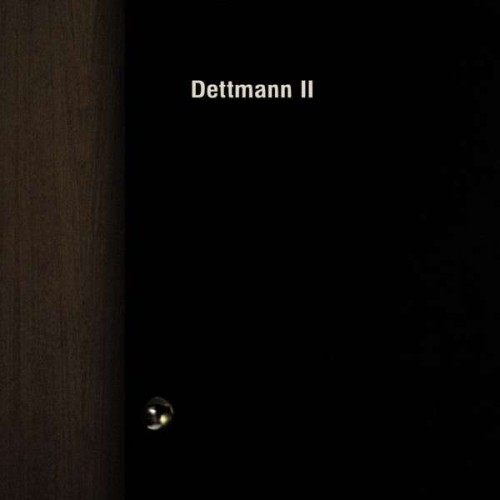La rappresentazione dell’ossessivo, l’attrazione per l’industriale e il meccanizzato, l’assenza di umanità, la simbiosi col ritmo del progresso, la dance come riflessione sul nostro rapporto col futuro. Delle basi filosofiche della techno se n’è storicamente parlato fino al limite della speculazione, e non è un caso che oggi per molti la techno sia Marcel Dettman e Marcel Dettmann sia la techno, almeno per quel che riguarda la frangia teutonica elevatasi a tempio del genere negli ultimi anni. Perché Dettmann ne incarna tutte le sfumature, sia sul più intellettuale formato album, sia in quella dimensione live comprensibilmente più compiacente verso il pubblico da festival, e un’analisi sul producer tedesco porta comprensibilmente a un ragionamento sulla techno tutta, sul suo stato di forma e soprattutto sui suoi limiti attuali, che ci sono e non vanno messi sotto silenzio.
Già, perché di techno ne parlavamo con piacere fino a qualche mese fa come un genere rivitalizzato dall’ingresso di forze giovani con voglia di farsi notare (quali son stati in questi anni i vari Blawan, Pariah, Midland, Joy Orbison, Duct o Untold), ma a posteriori non si identificano veri segni di rinnovamento apportati dai nuovi ingressi, se non per le piccole influenze che si è portato dietro chi veniva dall’old-school dubstep (alle quali hanno contribuito anche i cambi di rotta operati da Scuba, Ramadanman o Pinch). A maggio era Boddika a dirci che, nonostante la nuova linfa, la scena techno era di nuovo al limite di saturazione, e il motivo non è l’overloading di produttori con la voglia di raccattare qualche soldo o un po’ di fama via Beatport, ma l’assenza di nuovi impulsi sonori che possano rispondere all’innata voglia di novità e spinta in avanti che in passato ha prodotto gli apici storici del genere (la prima onda di Detroit, Basic Channel e gli inizi minimal, al di là dei gusti personali).
E senza nuove idee da espandere, diventa facile che i dischi si somiglino un po’ tutti: tra nomi come Ben Klock o Shed, Marc Houle o Benjamin Damage, non si riscontrano forti elementi di distinzione, tutti sembrano interpreti di uno stile ormai prossimo a diventare poco più che un cliché, orientato al dj tool o al massimo ai veri appassionati di genere. Le eccezioni ovviamente ci sono (ve ne citiamo giusto due riguardo ad album usciti di recente: Kyle Hall e Marcel Fengler) ma, almeno a questo giro, non riguardano Marcel Dettmann: “Dettmann II” non fa niente di dissimile da “Dettmann I” né dai lavori dei personaggi che dicevamo prima, insiste su quel che dal tag “techno” ci si aspetta (le ipnosi minimaliste di “Lightworks”, l’intransigenza cattiva di “Throb” e “Radar”, le spirali di alienazione di “Corridor”) e concede pochissimo a spunti di qualsiasi altra natura (qualche fugace parentesi ambient, più gli spazi emotivi di “Seduction”, dove in realtà è il feat. di Emika ad apportare la femminilità e gli elementi attraenti che l’han fatta apprezzare nei suoi album). Un cerchio perfetto di rigidità e fedeltà alla propria immagine che può facilmente essere scambiato per staticità. Da non intendere in senso negativo: l’album merita di essere ascoltato e dà esattamente cosa gli si chiede. Ma semplicemente, detto senza che sembri una stroncatura, non ti avvolge e non ti trascina come fanno quei dischi dotati dello stile e del carattere di chi prova a dire qualcosa di nuovo, o comunque di offrire il proprio singolare punto di vista sulle cose.
Quella di Dettmann invece è, in altre parole, la techno che si guarda allo specchio. Qualcosa che, a dire il vero, in questo momento sta facendo anche la house, per mano di “nuovi conservatori” come Maya Jane Coles, Dusky, Julio Bashmore o Bicep. Ma mentre la sinousa collega dei 4/4 riflette (e si riflette) sui piaceri che possono ancora scaturire dal processo di perfezionamento dei suoi stilemi noti, la techno di oggi sta cercando ansiosamente la prossima scheggia di futuro da inseguire. E fino a quando non l’avrà trovata, sembrerà sempre più spesso come in quest’album: incazzata con sé stessa.