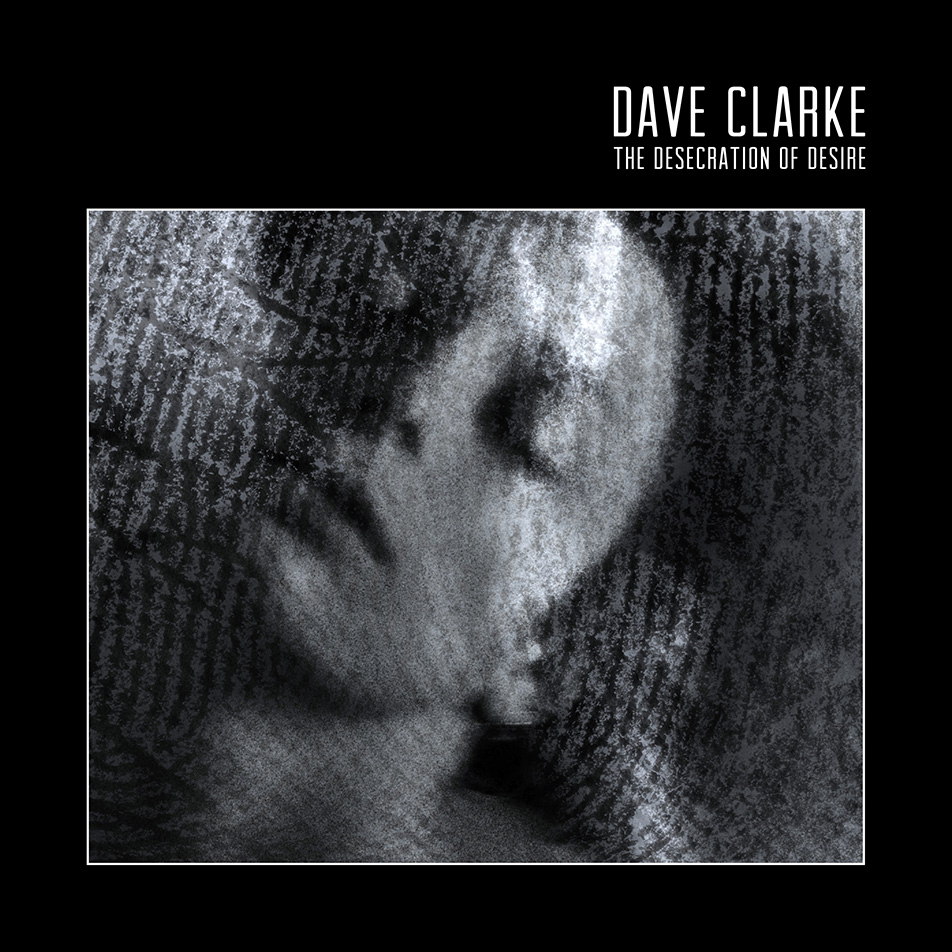Ecco: questo disco “è” Dave Clarke. Al 100%. E riesce ad esserlo andando ad avventurarsi in sentieri che non sono apparentemente quelli suoi abituali, quelli cioè per cui è conosciuto in tutto il mondo e quelli in cui voi lettori soundwalliani giustamente lo infilate. Perché delle dieci tracce di “The Desecration Of Desire” giusto una, “Plasmatic”, potrebbe trovare buona e continua vita sui dancefloor techno: solida, efficace, coi bpm giusti, un tiro più che buono. Ok. Per il resto, però, si sta ben lontani dall’energia danzereccia. Proprio ben lontani. Clarke, che torna al formato album dopo tempo immemorabile (anno 2003, “Devil’s Advocate”), ripercorre la formula del tentativo precedente: un disco cioè vario, con ospiti non dance ma particolari, “di peso” in campi altri rispetto alla club culture più canonica. Se nell’LP precedente trovavi infatti Chicks On Speed o Mr. Lif, non propriamente dei dj di fama, qui ci sono sua santità grunge Mark Lanegan o quel personaggio molto particolare che è Gazelle Twin.
Quello che è paradossale, è che se nel 2003 Dave Clarke era sulla cresta dell’onda col mondo ai suoi piedi (anche oggi è un peso massimo, sia chiaro, ma non è più “il” dj techno) e poteva quindi fare le cose in scioltezza, il risultato dell’ambizioso tentativo dell’album non-solo-dance lì falliva, per mancanza di precisione, senso della misura, messa a fuoco, forse proprio umiltà. Cosa che invece non accade assolutamente quattordici anni dopo. Sarà l’esperienza; sarà l’averne viste tante; sarà proprio il fatto di non essere più considerato nell’Olimpo (perché al posto suo ora ci sono quelli che stazionano ad Ibiza nelle stagioni estive, sciacquando i panni in acque tech-house un po’ minimal, un po’ essenziali, un po’ allegrotte); sta di fatto che in “The Desecreation Of Desire” è molto più a fuoco. Chirurgico, quasi.
Una cosa meravigliosa di questo disco è che è inattuale. Ovvero, non zompa o tenta di zompare su nessuno dei trend odierni. Paradossalmente, in realtà lo fa pure: perché è proprio ascoltando questo album che si intravedono bene le nervature che connettono techno ed industrial, techno ed EBM, techno e post punk, faccenda che oggi pare un vestito molto comune da indossare fra chi si considera un appassionato di livello di elettronica. Ma mentre oggi la scuola comune è quella che si rifà, più o meno, a quello che passa per festival come Atonal o Unsound, ovvero lì dove ci sono un sacco di nebbie, riverberi, apocalissi più nere del nero, Clarke sceglie invece un procedimento molto anni ’90: lascia i suoni asciutti, non li maschera, non ne deforma i confini, le citazioni sono chiare, l’approccio verso il rumore digitale è lineare, semplice, comunicativo, quasi banale, di certo non iper-intellettualizzato.
Esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare se volesse dimostrare di essere figo, al passo coi tempi, perfettamente aggiornato con gli hype più recenti. Evidentemente, non gliene frega un cazzo: ed in questo, sì, in questo è appunto Dave Clarke al 100%. Un artista di enorme esperienza, di spessore vero, di sguardo acuminato. Un artista che forse irrimediabilmente ha perso il titolo di superstar dj (il suo turno è stato in passato, lui da tempo ha smesso di far alcunché per farlo tornare), ma che ora con la sicurezza dell’età adulta marcia tranquillo sulla sua strada, non si vergogna dei suoi gusti e delle sue passioni, fa quello che gli pare. E lo fa bene. Con chiarezza ed efficacia. Perché è bravo. Molto più bravo e solido di un sacco di artisti oggi celebratissimi, quelli che piacciono alla gente che piace.