In un giovedì di metà ottobre, Cracovia indossa un meraviglioso abito autunnale e attraversandola di corsa, dall’affascinante periferia post-sovietica al pittoresco centro gotico-rinascimentale, si rivela più bella a ogni angolo, avvolta nella morbida luce del pomeriggio. In questi giorni, oltre ad essere cosparsa di foglie e inondata di sole, Cracovia è stata il teatro dell’Unsound. Festival nella mia agenda da tempo ma a cui arrivo quest’anno per la prima volta, carica di aspettative e di curiosità: una fetta – spesso ipercritica – del pubblico internazionale lo descrive praticamente da sempre come la mecca di avanguardie e avanguardisti (dato confermato ogni anno dal sold-out nel giro di qualche millisecondo) e le edizioni precedenti rivelano la concezione trasversale del festival che, sullo scheletro di line-up stellari, poliedriche e spesso antesignane delle tendenze del prossimo futuro, costruisce una riflessione multiforme su temi chiave del nostro mutevole presente, riflessione che va ben oltre un programma di performance e after-party.
E anche in questa edizione 2018, intitolata “Presence”, l’Unsound pone delle domande urgenti: cosa significa essere “presenti”, oggi? Come possiamo ripensare la nostra esistenza, il nostro esserci (il dasein heideggeriano) in una realtà saturata dai media, manipolata dalla tecnologia, frammentata da una comunicazione abnorme ma effimera? E in ambito musicale, possono il processo creativo e l’esperienza dell’ascolto opporsi al consumismo fagocitante che riduce tutto a prodotto, condannandolo al decadimento istantaneo?
Per provare a rispondere a queste domande o almeno a solleticare le coscienze, il festival offre un programma fittissimo e complesso, che sembra richiedere un’onnipresenza in contrasto con il tema di quest’anno, visto che copre quasi ogni ora della settimana dal 7 al 14 ottobre e impone uno studio preliminare e un’accurata selezione a chi non voglia viverne soltanto la schedule notturna, pur succulenta di suo. Workshop, conferenze e gruppi di lettura, sessioni broadcast, proiezioni cinematografiche, mostre e installazioni rappresentano infatti il volto diurno del festival ma non sono lì a far da contrappeso intellettuale alle atmosfere rave della notte: no, stabiliscono con esse una continuità e una complementarietà che non avevo mai sentito così forti e autentiche in altri eventi simili.
In genere si sceglie di andare ad un festival perché incarna il nostro gusto, perché la line-up è un po’ il nostro olimpo personale, perché è in linea con quello che cerchiamo nella musica. E invece all’Unsound si va per l’Unsound
Purtroppo, essendo qui solo per il long-weekend, perdo alcune delle proposte per me più interessanti in questo senso, prima fra tutte il reading-group su Mark Fisher e sulla raccolta postuma “K-punk” e non ultime poi i talk sul rapporto tra robotica e pornografia, sull’impatto dell’intelligenza artificiale su creatività ed estetica, sul senso dell’attivismo politico nell’era dell’engagement online. Ma anche a partire da giovedì, giorno in cui la bilancia della programmazione inizia a pendere verso eventi più club-oriented, gli incontri su industria musicale e salute mentale e su fake news e controllo informatico, il panel sull’ascesa dei populismi e sui nuovi linguaggi di protesta e infine il workshop “Music journalism” mi danno il polso di come questa impressionante lista di progetti non strettamente musicali non sia una semplice lista ma un mosaico organico, curato ma accessibile, di input e idee che fa da fondamenta piuttosto che da cornice alla musica, che resta comunque il core dell’Unsound.
La larga partecipazione a questa parte del festival, la professionalità e l’impegno che vi stanno dietro e la coesione che lega al tema “Presence” le tante questioni sollevate sono un segno di quanto l’Unsound sia un evento politico, prima ancora che di intrattenimento. Una piattaforma di aggregazione e convivenza, di confronto e contaminazione. Uno spazio di ricerca e scoperta. Un progetto profondamente umano, che rivela e tradisce umanità nell’atmosfera empatica e accogliente che si respira e nelle imperfezioni che ogni tanto affiorano in una produzione di alto livello ma lontana dalle macchine infallibili e impersonali che muovono altri festival europei.
La prima imperfezione impedisce a me e ad altre decine di persone di vivere sin dall’inizio il concerto di Terry e Gyan Riley: il maestro del minimalismo suona insieme al figlio, virtuoso della chitarra, a Wieliczka, in una miniera di sale a 150 metri sottoterra, uno dei luoghi più incredibili che Cracovia offre e che l’Unsound reinventa. La particolarità della location (si scende a velocità supersonica, in venti alla volta, letteralmente spinti dagli operai polacchi dentro ascensori industriali non a prova di claustrofobia) e la riferita “lack of communication” tra festival e gestori della miniera bloccano gli accessi proprio quando Lucretia Dalt cede il palco ai Riley. La fila in parte si dissolve, in parte resiste al freddo, riuscendo a raggiungere una spettacolare cava di sale illuminata da file di lampadari di cristallo e a godere l’ultimo quarto di un’ora magica in cui i loop ipnotici del padre tessono un dialogo intimo e polistrumentale con gli assoli jazz del figlio, dando voce alle tante influenze world dell’universo rileyiano. Magia.
Foto Michal Ramus

Riemergo sulla superficie terrestre con lo spirito leggero e il sorriso sulla faccia e scorgo lo stesso effetto sui visi delle altre centinaia di persone, compresse in modo un po’ selvaggio nei due autobus che ci riportano in città: altra piccola imperfezione organizzativa, ma i Riley hanno trasformato tutti in monaci tibetani. La destinazione è l’Hotel Forum, gigantesco edificio brutalista: albergo di lusso in epoca sovietica di cui ha mantenuto anche gli interni, con tetti bassi, pannelli di legno e moquette (non potrò mai più ballare su niente che non sia moquette). L’Hotel Forum ospita da tempo la programmazione notturna dell’Unsound e anche quest’anno le sue quattro sale, Ball Room, Chandelier Room, Kitchen e Secret Lodge, vibrano dei sound più diversi. La timetable delle tre serate dal giovedì al sabato è fitta da far paura, un ventaglio aperto tra leggende e new-comers, tra club music e sperimentazione colta, tra nomi di punta dell’elettronica mondiale e figure emergenti da un sottobosco tutto da scoprire. Segno un paio di must-listen ma ho subito la sensazione che la grande ricchezza dell’Unsound sia proprio quella della scoperta ed è da questa sensazione che mi lascio guidare in tre notti che sembrano continuare l’una nell’altra. In realtà l’umanità che le popola cresce in numero e in eterogeneità dalla “Keep me in CC” del giovedì, dove mi sento un po’ ad un convegno di archeologia della sneaker, alla “Simulator Sickness” del sabato, in cui le interazioni si fanno più variegate.
Giovedì gli enormi spazi della Ball room sono inaugurati dal set neo-industrial di jjijijijj, DJ del collettivo Intruder Alert di Varsavia e primo di una lunga serie di act polacchi che rappresenta uno dei punti di forza di tutto il festival, una finestra aperta su un’incredibile scena locale, poco nota nel nostro pezzo di Europa. Lo slot di Lotic dà il via ad una delle vene più pulsanti di questo Unsound, quella di artisti che fanno della fluidità di genere – musicale e sessuale – il senso della propria ricerca. Segue l’adrenalinico e tuonante assolo dello straordinario batterista polacco Adam Golebiewski – altra scoperta – che scende dal palco per una performance prepotentemente fisica in mezzo alla gente. I live di JASSS e Blawan e il DJ-set di Ben UFO si susseguono in Ball Room, ma ho troppa voglia di esplorare l’ignoto e migro tra Chandelier e Kitchen: non me ne pento neanche per un secondo perché resto folgorata dal complesso live coding autechriano di Renick Bell, dall’amalgama arabo-futurista della tunisina Deena Abdelwahed, dal viaggio poliritmico di Hubert Zemler, altro virtuoso percussionista polacco, e dagli irresistibili blend di footwork, afrobass e grime di RP Boo e degli affiliati di Nyege Nyege Tapes, l’ugandese DJ Kampire e il kenyano Slikback.
Foto Scott Robertson
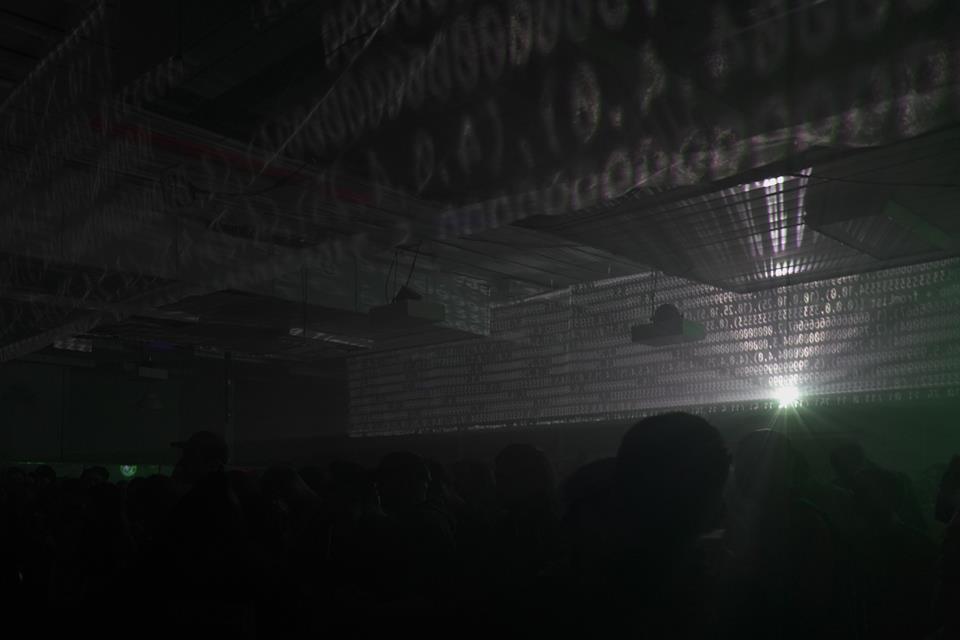
Il giorno dopo perdo però quella che da molti è stata definita una delle performance chiave di quest’anno: il nuovissimo centro congressi ICE è il teatro della premiere di ”Magna Surgat”, visionaria collaborazione multimediale tra Rabit, il collettivo House of Kenzo e il videoartista Sam Rolfes, che in motion-capture traspone in 3D in tempo reale le movenze dei performer texani sulle sperimentazioni sonore del fondatore della Halcyon Veil. I racconti sono entusiasti, mea maxima culpa non poter fare il mio.
Foto Theresa Baumgartner

La sera si ritorna all’Hotel Forum e di nuovo ci sono scelte e rinunce da fare per essere presenti ed evitare un superficiale ping-pong tra le sale. Scelgo (per fortuna) il live di Davy Kehoe e compagni, intreccio kraut rock di voce, basso e armonica, venato di uno humor enigmatico e tagliente in pieno stile Wah Wah Wino. Il big name di stasera è certamente SOPHIE e un bel po’ di gente è qui solo per lei: non è il mio caso, ma voglio cogliere l’occasione di ascoltare una delle artiste più celebrate degli ultimi anni. La mia impressione è tiepida, forse dipende anche dall’atmosfera da raduno fan ma la continua oscillazione tra hit pop e sprazzi di sperimentazione, sua (acclamata) firma, mi suona debole e abbozzata. Sarà l’età (mia). L’act successivo invece è epico e diventa uno dei miei highlight del festival: il live industrial-techno degli hardware freaks Manni Dee ed Ewa Justka mi ricorda quanto c***o amo saltare di fronte ad un muro di casse, sarà di nuovo l’età ma sono felice così. Il running-order in Ball room a questo punto segna due back to back sulla carta imperdibili, Lena Willikens b2b Objekt ed Elena Colombi b2b Olivia, quest’ultima figura di riferimento della scena cracoviana, resident dell’Unsound e fondatrice del collettivo Chrono Bross. Set perfetti ma li ascolto un po’ a sprazzi (pessimo approccio ad un back to back) perché intanto c’è un Kode9 in stato di grazia che mi inchioda fino all’ultima traccia in una Chandelier piena di bassi, corpi ed energia. E se il peso specifico di Kode9 non è una sorpresa, di certo lo è l’argentina Tayhana, con la sua audace traduzione di cumbia, reggaeton e altre sonorità latine in un dirompente linguaggio da club. Ma in questo delirio di bassi, basta scendere nella Secret Lodge, nei sotterranei dell’Hotel Forum, per trovarsi improvvisamente in una scena di Twin Peaks: silenzio ovattato, buio e qualche luce rossa, tende di velluto, divani tondi e piano bar anni ‘80 (il miglior bar del festival), questo lo sfondo di uno showcase di artisti locali, tra i quali segnalo un altro mostruoso batterista, Jan Mlynarski.
Foto © Helena Majewska

Sabato è uno dei giorni che ho atteso di più e con il senno di poi, a ragione: le magistrali performance di Drew McDowall e Jlin, che si tengono prima del tramonto negli spazi dell’ICE, per me valgono il festival. Non so quante volte avrò dilatato/ripiegato/curvato/avvolto/spiralizzato il tempo con l’ascolto di quel capolavoro che è “Time Machines”, e immergermi dal vivo nelle sue frequenze psicotrope è un’esperienza che non ho paura di definire mistica. Nel riproporre questo disco leggendario, che nel 2018 ha compiuto vent’anni, l’ex-Coil collabora con l’artista visuale Florence To in una performance A/V memorabile che lascia un po’ tutti senza parole, con la pelle d’oca e la coscienza espansa.
In queste sublimi condizioni attendo il live di Caterina Barbieri, che come una creatura angelica propaga nell’auditorium i suoni della sua narrativa modulare di memorie collettive, accompagnata dai visual di Ruben Spini. Inizia qui uno dei momenti migliori di questa edizione dell’Unsound, la premiere europea di “Autobiography”, collaborazione tra Jlin e il coreografo britannico Wayne McGregor (figura fondamentale della danza contemporanea) con la sua compagnia. “Autobiography” è il più recente lavoro di McGregor, che lo ha concepito come algoritmo espressivo del suo genoma sequenziato, e lo score, commissionato a Jlin e uscito quest’anno su Planet Mu, è un capolavoro nel capolavoro. Lo show viene presentato in una versione compatta, adatta ai tempi di un festival, ma è una blessed hour: un magnetismo invisibile ma evidente lega i movimenti superbi dei danzatori alla sinfonia sciamanica della produttrice americana, che dall’arioso minimalismo iniziale fiorisce in una sinuosa furia percussiva. L’intero progetto è eccezionale, nella concezione e nell’esecuzione.
Foto Michal Ramus

Potrei anche godermi questo momento di estasi e lasciarlo sedimentare ma faccio il pieno di proteine e acidi grassi saturi d’origine suina e torno all’Hotel Forum. Non faccio in tempo a sentire il live ambient di Huerco S. (…rimpiantino!) e arrivo per Amnesia Scanner: il duo, alla sua terza apparizione all’Unsound, presenta “AS Oracle”, show concepito appositamente per il festival polacco e in cui il pubblico è invitato ad interagire virtualmente con un’entità AI su un network attivato durante la performance. Il live è un manifesto della deconstructed club music, il complesso non-genere che comprende in sostanza tutto ciò che di nuovo è emerso negli ultimi anni nel già difficilmente incasellabile mondo dance: la spregiudicata mescolanza dei sound più diversi e il loro contestuale superamento, il post-everything – che piaccia o no – è il marchio del presente e innegabilmente gli Amnesia Scanner ne sono stati profeti e ne sono sommi rappresentanti. Alla mia domanda “What genre is this?” Oracle risponde “Encrypted hard music with rave signatures” e non trovo parole migliori per raccontare l’ibrido caotico e stridente del loro live. E ironicamente, mentre cerco inutilmente di processare il messaggio criptato degli AS, la Ball room viene pervasa da una 90s-nostalgia, premessa del post-everything, impersonata da The Mover aka Marc Acardipane, padrino dell’hardcore-gabber, e poi da DJ Storm, leggenda della d’n’b (per i non devoti, co-fondatrice Metalheadz con Goldie e Kemistry). Un live un po’ deludente il primo, un set impeccabile il secondo: la mia sensazione è che Acardipane stia giustamente cogliendo l’attimo del revival gabber, genere che ha praticamente inventato, mentre DJ Storm è l’inossidabile portavoce di una scena immortale nel cuore e nelle ginocchia di molti. Le ultime ore dentro l’accogliente mostro di cemento sono tutte a cura di una monumentale Shyboi, che con un set semplicemente perfetto, aggressivo, erotico e irresistibile, trasforma la Chandelier room in un warehouse party indimenticabile. Andando a prendere a bere ascolto qua e là il set Skee Mask b2b Zenker Brothers ma non c’è storia: Discwoman >>> Ilian Tape.
Foto Helena Majewska

La domenica chiude il festival con un drastico cambio di location: in memoria di Jóhann Jóhannsson si apre lo Slowacki, uno dei principali teatri di Cracovia, che ospita “Memory”, concerto-tributo molto atteso e promosso dall’Unsound come uno degli eventi chiave della settimana. Si rivela per me come forse l’unica vera profonda delusione del festival: curato da Hildur Guðnadóttir, Sam Slater, Erik K. Skodvin e Robert Aiki Aubrey Lowe, amici e collaboratori del compositore islandese scomparso quest’anno, e da Sinfonietta Cracovia, il concerto risulta sorprendentemente banale nella scrittura e drammaticamente improvvisato nella realizzazione, quasi non fosse stato mai provato. Inspiegabile alla luce degli artisti coinvolti e del tributo a Jóhannsson. Non capisco gli applausi che sento sgattaiolando via dal teatro, sarà l’istituzionalità del luogo e dell’occasione o proprio non ho capito niente io? Propendo per la prima, dato che per le scale poi incrocio altri sguardi smarriti e commenti sarcastici. Con un po’ d’amaro in bocca (e una febbre da mediterranea vittima dell’autunno mitteleuropeo) rinuncio al free party conclusivo che si tiene al Kamienna, ex magazzino ferroviario, e ai set di Bill Kouligas e Powder per cui un po’ rosico ancora.
Foto Slawek Zielinski

Lunedì una magnifica colazione ipercalorica mi rimette al mondo e Cracovia mi regala un’altra stupenda giornata di sole, stavolta event-free, che trascorro a zonzo per le sue strade, tra altre calorie e un po’ d’immancabile digging (segnalo Paul’s Boutique, Records Dillaz e Hi Fidelity). Ed è una giornata per mettere a fuoco le mie impressioni. Sono tante le performance che ho perso arrivando solo giovedì: Tim Hecker, Dengue Dengue Dengue, Andrea Belfi e Valerio Tricoli, Lea Bertucci, GAIKA, Eartheater. Altrettante quelle che ho perso “per scelta”. Ma sono comunque giorni che valgono mesi, musicalmente parlando: l’Unsound è una fotografia caleidoscopica del sound of now e regala una percezione piuttosto nitida di quali strade l’elettronica stia percorrendo o si appresti a percorrere, percezione che difficilmente altri eventi sono in grado di veicolare. In genere si sceglie di andare ad un festival perché incarna il nostro gusto, perché la line-up è un po’ il nostro olimpo personale, perché è in linea con quello che cerchiamo nella musica. E invece all’Unsound si va per l’Unsound. All-inclusive. All’Unsound si va per espanderli i gusti, per ascoltare artisti di cui non si sospettava nemmeno l’esistenza, per trovare nella musica altro rispetto a quello che si era sempre cercato. Ci si trova così in un crocevia intricatissimo di persone, idee e progetti provenienti letteralmente da tutto il mondo, in una rara e preziosa dimensione transnazionale più che internazionale. E altrettanto rara è la freschezza e la normalità con cui il programma è di fatto dominato da donne e artist* non-binar*: è semplicemente la fotografia del presente, non il frutto di una politica inclusiva neopuritana, forzata e intollerante.
La deconstructed club music, che in fondo è stato il filo conduttore del festival, celebra un po’ la fine dell’idea del club come luogo di piacere ed evasione, consacrandolo a contenitore delle fisiologiche ansie di una generazione che balla poco e pensa molto
Pur nella sua autenticità e nella sua schiettezza, l’Unsound fa capo a una concezione decisamente cerebrale della musica, e dai teatri ai club non si respira mai l’edonismo spinto che permea altre realtà non troppo lontane. E mi pare che questo sia perfettamente in linea con i temi che sottendono le più vive tendenze contemporanee: la deconstructed club music, che in fondo è stato il filo conduttore del festival, celebra infatti un po’ la fine dell’idea del club come luogo di piacere ed evasione, consacrandolo a contenitore delle fisiologiche ansie di una generazione che balla poco e pensa molto. E questo presente così frammentario, mentale e narcisista e però così incredibilmente aperto, stimolante e provocatorio l’Unsound lo ha raccontato alla perfezione.
Foto in testa articolo: Helena Majewska


